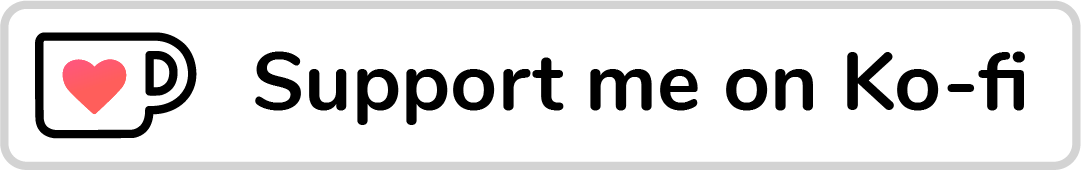Israele, USA e Iran: la guerra è appena cominciata – Parte I
Il vecchio sogno neocon di ridisegnare il Medio Oriente attraverso una serie di cambi di regime a vantaggio di USA e Israele, archiviato per una decina d’anni, è tornato alla ribalta.

Nota di servizio: la seconda parte di questo articolo uscirà la prossima settimana.
L’improvviso cessate il fuoco “imposto” a Israele ed Iran lo scorso 24 giugno dal presidente americano Donald Trump, in quella che molti hanno ribattezzato “la guerra dei dodici giorni”, con ogni probabilità non segna la fine delle ostilità bensì l’inizio di un più ampio e pericoloso scontro per l’egemonia in Medio Oriente, con possibili ramificazioni globali.
I dodici giorni di conflitto a cui abbiamo assistito costituiscono un destabilizzante salto di qualità nel confronto fra Israele e Iran, passato dalla “guerra ombra” degli scorsi decenni a uno scontro militare diretto.
Nel primo caso, l’Iran aveva impensierito Israele soprattutto attraverso i suoi alleati regionali, Hamas e Hezbollah in primo luogo. Israele, dal canto suo, aveva condotto una serie di operazioni sotto copertura – azioni di sabotaggio e omicidi mirati – in territorio iraniano, spesso sfruttando partner locali.
Nel secondo, i due paesi hanno reciprocamente colpito i rispettivi territori con attacchi militari diretti (sebbene a distanza visto che essi non sono confinanti). Le prime avvisaglie di questo salto di qualità si sono avute con gli “scambi missilistici” avvenuti fra i due paesi nell’aprile e nell’ottobre del 2024.
Sia nella “guerra ombra” degli scorsi decenni che nello scontro diretto conclusosi il 24 giugno, Israele è stato supportato dagli Stati Uniti.
“I veri uomini vogliono andare a Teheran”
Fin dalla rivoluzione del 1979, allorché l’Iran è uscito dal sistema americano di alleanze nella regione, la Repubblica Islamica è stata considerata da Washington come un nemico da eliminare.
L’approccio americano è rimasto invariato anche dopo che la spinta rivoluzionaria iraniana perse la sua propulsione iniziale e divenne evidente che essa non si sarebbe estesa al di fuori dell’Iran.
A partire dall’inizio del nuovo millennio, il paese è stato per anni l’ambito trofeo finale di un piano neocon volto a ridisegnare il Medio Oriente in modo da assicurare definitivamente l’egemonia israelo-americana nella regione.
Tale obiettivo era chiaramente esplicitato in un documento redatto nel 1996 da un gruppo di strateghi neocon guidati da Richard Perle, intitolato “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm”.
Negli anni dell’invasione americana dell’Iraq era in voga nei circoli neocon una frase che sarebbe stata originariamente pronunciata da un alto funzionario britannico: “Tutti vogliono andare a Baghdad. I veri uomini vogliono andare a Teheran”.
Ancora nel 2009, l’idea di un cambio di regime in Iran era pienamente in voga nei corridoi dell’establishment americano, come conferma un rapporto della Brookings Institution (tra i più influenti think tank USA) intitolato: “Which Path to Persia? Options for a New American Strategy toward Iran”.
Il 5° capitolo del rapporto, dal titolo “Leave it to Bibi: Allowing or Encouraging an Israeli Military Strike”, appare di una straordinaria preveggenza.
Dopo i fallimenti di George W. Bush in Iraq e Afghanistan, e dopo la sconfitta di Israele nella guerra con Hezbollah in Libano nel 2006, i piani neocon per il Medio Oriente erano però passati progressivamente in secondo piano.
Archiviato l’ennesimo fallimento in Siria, dove Washington aveva tentato un nuovo cambio di regime sull’onda delle rivolte arabe del 2011, l’amministrazione Obama aveva cercato di realizzare l’annunciato “pivot” verso l’Asia per contenere l’ascesa cinese e aveva sostenuto la rivolta di Maidan a Kiev in chiave antirussa nel 2014.
Un anno dopo, proprio in vista di un progressivo disimpegno dal Medio Oriente, Obama aveva raggiunto un accordo con Teheran, il cosiddetto Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), per archiviare la questione nucleare e trovare un fragile modus vivendi con l’Iran. Ciò avrebbe permesso a Washington di guardare altrove.
Negli anni seguenti, l’attenzione dei presidenti americani sarebbe stata risucchiata dalla contrapposizione con Mosca in Ucraina, dalla guerra commerciale con Pechino, e più in generale dalla rinnovata “competizione fra grandi potenze”.
A Washington il Medio Oriente era caduto nel dimenticatoio, portando a un raffreddamento dei rapporti con alleati storici come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, e ad una sempre più marcata penetrazione economica cinese nel Golfo.
Nuovi piani USA in Medio Oriente
Accortasi della perdita d’influenza in Medio Oriente, nel 2023 l’amministrazione Biden ha pianificato un ritorno americano nella regione, fondato su nuovi accordi di sicurezza con i principali partner degli USA nel Golfo, sul rilancio degli Accordi di Abramo introdotti dal predecessore Donald Trump per normalizzare i rapporti fra Israele ed i paesi arabi, e sull’annuncio di un corridoio economico – l’India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) – che avrebbe dovuto cementare la nuova architettura di sicurezza americana nella regione sotto il profilo logistico e degli scambi commerciali.
L’IMEC si proponeva come chiara (quanto supponente) alternativa alla Belt and Road Initiative (BRI, la “via della seta” cinese) con l’obiettivo di tentare di arginare la penetrazione di Pechino.
Gli accordi di Abramo avevano lo scopo di creare un fronte regionale arabo-israelo-americano finalizzato ad isolare l’Iran ed i suoi alleati regionali del cosiddetto “Asse della Resistenza” (Hamas, Hezbollah, Siria, milizie sciite in Iraq, e Ansar Allah nello Yemen).
Questo schema sarebbe stato però messo a soqquadro dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e dalla violentissima risposta militare israeliana, destinata a suscitare la reazione di Hezbollah in Libano, delle milizie sciite irachene, e di Ansar Allah (noti anche come gli “Houthi” dal nome del loro fondatore) in segno di solidarietà con Hamas e con i palestinesi di Gaza.
La nuova destabilizzazione del Medio Oriente metteva in discussione l’intera architettura dell’IMEC e degli Accordi di Abramo: un corridoio economico non avrebbe mai visto la luce in un’area squassata dai conflitti, e una normalizzazione dei rapporti (in particolare) fra Arabia Saudita e Israele era impensabile mentre l’esercito di Tel Aviv sterminava i palestinesi.
Per questa ragione l’amministrazione Biden, pur senza mai negare l’appoggio logistico e la fornitura di armi essenziali al funzionamento dell’operazione militare israeliana, ha più volte cercato di scoraggiare i piani israeliani di allargamento del conflitto su scala regionale, proponendo invece una soluzione politica a Gaza che però il governo Netanyahu ha sempre rifiutato.
La svolta del settembre 2024
La svolta che ha contribuito a far cadere le perplessità di molti strateghi americani e di diversi esponenti dell’amministrazione Biden è rappresentata dall’impressionante operazione condotta dall’esercito israeliano in Libano il 27 settembre 2024, che ha portato all’eliminazione del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e alla decapitazione dell’intera leadership del gruppo.
Quell’operazione – imperniata su un’agghiacciante capacità di penetrazione d’intelligence che ha permesso a Israele di ricostruire con estrema precisione gli spostamenti dei principali leader del movimento libanese, e di colpire al momento opportuno con effetti devastanti – ha spinto molti a Washington a rivedere le proprie posizioni.
La prospettiva di infliggere un colpo mortale a un secondo anello dell’asse filo-iraniano, dopo il ridimensionamento militare di Hamas a Gaza, ha spinto esponenti politici ed esperti a Washington a ritenere percorribile la strategia di impiegare Israele come “ariete” per scardinare l’asse della resistenza e isolare l’Iran.
E’ interessante ricordare che proprio in quell’occasione Jared Kushner, genero di Trump (allora impegnato nella campagna presidenziale), scrisse in un lungo post su X (Twitter) che Hezbollah era un’arma puntata alla tempia di Israele. Tale arma aveva impedito fino a quel momento la distruzione delle installazioni nucleari iraniane.
Senza Hezbollah, sosteneva Kushner, l’Iran era molto più debole, ed esposto a un possibile attacco.
Simili convinzioni si sono ulteriormente rafforzate a Washington dopo la rocambolesca caduta di Bashar al-Assad in Siria, nel dicembre del 2024, e il successivo smantellamento del residuo apparato militare di Damasco ad opera di una sistematica campagna israeliana di bombardamenti, che ha lasciato lo spazio aereo siriano sotto il pieno controllo di Israele.
Il vecchio sogno neocon di ridisegnare il Medio Oriente attraverso una serie di cambi di regime a vantaggio di USA e Israele, archiviato per una decina d’anni, stava riemergendo prepotentemente e in maniera del tutto inattesa.
Il crollo di Assad lasciava Hezbollah isolato nel vicino Libano, ed enormemente indebolito dal durissimo scontro militare con Israele conclusosi con il cessate il fuoco del 27 novembre (costantemente violato da Tel Aviv).
Gaza, senza altri appoggi ad eccezione di quello limitato di Ansar Allah dal remoto Yemen, rimaneva ad affrontare il suo tragico destino in solitudine.
A est della Siria, ormai del tutto inoffensiva, gli USA continuavano ad esercitare una notevole influenza in Iraq ed a controllarne lo spazio aereo.
Vi era dunque una “finestra di opportunità”, scrivevano i commentatori israeliani, per colpire le installazioni nucleari iraniane alla luce dello stato di debolezza e isolamento in cui si trovava Teheran, e dell’esistenza di un corridoio sicuro per arrivare al confine iraniano attraverso i cieli di Siria e Iraq.
A cosa serve il programma nucleare di Teheran
A questo punto è importante chiarire che il programma nucleare iraniano è stato un utile pretesto per attaccare militarmente l’Iran, ma non è il vero obiettivo che ha determinato quest’azione.
Come ha scritto l’analista Sina Toossi, il programma nucleare di Teheran non va interpretato come una “crociata ideologica per entrare in possesso della bomba”, ma come uno strumento calibrato per raggiungere obiettivi di deterrenza e di potere contrattuale in sede negoziale.
Non bisogna dimenticare che, fin dalla sua nascita nel 1979, la Repubblica Islamica è stata sotto embargo economico e sotto costante minaccia militare, in particolare da parte americana (anche attraverso il sostegno di Washington ad attori regionali come Saddam Hussein durante la guerra Iran-Iraq del 1980-88).
Per uscire da quest’impasse, Teheran ha fatto ricorso a vari strumenti, fra i quali spiccano da un lato la creazione di un asse di alleati regionali che costituisse una sorta di fascia di sicurezza attorno all’Iran, e dall’altro lo sviluppo di un programma di missili balistici (in particolare per ovviare alla mancanza di un’aviazione militare) e del programma nucleare.
Attraverso quest’ultimo, Teheran è divenuta una potenza nucleare “latente” che, pur non avendo mostrato finora l’intenzione di costruire un’arma atomica, dispone della quasi totalità delle infrastrutture e delle conoscenze scientifiche per arrivare a produrla.
La strategia iraniana persegue molteplici obiettivi: impiegare gli elementi del programma nucleare come merce di scambio in sede negoziale per ottenere un’abrogazione delle sanzioni (che non riguardano solo il nucleare, ed in parte lo precedono), rafforzare gli strumenti che garantiscono la propria indipendenza politica, economica e scientifica in un ambiente generalmente ostile, e certamente mantenere aperta la strada verso la costruzione di un ordigno nucleare nel caso in cui si materializzi una minaccia esterna esistenziale.
Negli anni passati, i vertici politici iraniani hanno mostrato di essere disposti a non oltrepassare la soglia di potenza nucleare latente raggiungendo nel 2015 un accordo (il citato JCPOA) con l’amministrazione Obama.
Tale accordo poneva limiti verificabili al programma nucleare iraniano, e uno stretto regime di sorveglianza sulle installazioni nucleari del paese, in cambio di garanzie di sicurezza e della promessa dell’abrogazione delle sanzioni.
Come ho accennato in un precedente articolo, fu Trump nel 2018 ad uscire unilateralmente dall’accordo nucleare (che l’Iran stava rispettando) ponendo le premesse per la crisi attuale.
Malgrado ciò, secondo le più recenti stime dell’intelligence USA, l’Iran non ha riattivato il proprio programma nucleare militare (sospeso dal 2003), e avrebbe bisogno di altri tre anni per costruire un’arma atomica (miniaturizzando una testata e costruendo un vettore balistico in grado di ospitarla) qualora prendesse una decisione politica in questo senso.
E’ dunque evidente che il problema rappresentato dall’Iran agli occhi dei suoi avversari non è incarnato dal programma nucleare in sé, ma dalla volontà iraniana di non assoggettarsi all’architettura egemonica israelo-americana in Medio Oriente, che ne fa automaticamente un competitor a livello regionale.
E’ altrettanto importante notare che il governo guidato dal presidente riformista Masoud Pezeshkian (insediatosi il 30 luglio 2024) aveva fra i punti del proprio programma politico quello di riaprire il negoziato con gli USA per arrivare ad una riconciliazione con l’Occidente (un’impresa che prima di lui avevano già tentato, senza successo, figure come Mohammad Khatami e Hassan Rouhani, firmatario del JCPOA).
Il fronte interventista in Israele e negli USA
Malgrado l’avvio di negoziati fra l’Iran e l’amministrazione Trump nei mesi scorsi per risolvere pacificamente il contenzioso nucleare, nello stesso periodo si è però consolidato in Israele e negli Stati Uniti un “partito della guerra” determinato ad agire militarmente contro Teheran.
Tale partito era fortissimo innanzitutto in Israele, dove un’intera classe politica era favorevole alla prospettiva di un attacco. Il 13 giugno (quando l’operazione militare ha avuto inizio) essa ha espresso in massa (inclusi i membri dell’opposizione) il proprio appoggio al premier Netanyahu.
Durante la guerra dei dodici giorni, tutte le polemiche legate al 7 ottobre, alla liberazione degli ostaggi, alla gestione della guerra a Gaza, e allo scontro istituzionale in Israele, sono scomparse dall’orizzonte mediatico israeliano, lasciando il passo a un ricompattamento a livello politico e di opinione pubblica.
Due figure chiave nella pianificazione dell’attacco all’Iran sono state il direttore del Mossad David Barnea e il comandante dell’aeronautica militare Tomer Bar.
Un’altra figura essenziale, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Tzachi Hanegbi, ha avuto un ruolo di primo piano nell’ottenere il consenso del comandante delle forze armate Eyal Zamir.
Il benestare dell’esercito ha segnato una netta frattura rispetto al passato. Fin dal 2007, infatti, tutti i comandanti dell’esercito israeliano – da Gabi Ashkenazi a Benny Gantz, a Gadi Eisenkot – erano stati contrari all’idea di attaccare militarmente l’Iran.
Barnea, dal canto suo, ha trasformato radicalmente il Mossad, introducendo quelle innovazioni tecnologiche in materia di monitoraggio, tracciamento e sorveglianza, e di impiego dell’intelligenza artificiale, che hanno reso possibili le operazioni di “decapitazione” della leadership di Hezbollah in Libano e dei vertici militari in Iran, e gli omicidi mirati dei leader di Hamas da Beirut a Teheran.
Al pari di Netanyahu, Barnea era contrario all’accordo nucleare del 2015. Egli ha inoltre operato uno stretto coordinamento con la CIA, che a sua volta ha giocato una parte fondamentale nella preparazione della guerra dei dodici giorni.
Oltre al direttore della CIA John Ratcliffe, il generale Michael “Erik” Kurilla, comandante dello US Central Command responsabile della regione mediorientale, è stato un alleato essenziale di Israele all’interno dell’amministrazione Trump.
Diverse fonti indicano Kurilla come l’elemento chiave all’interno dell’amministrazione che ha portato ad approvare l’attacco contro Teheran.
Spesso descritto come radicalmente filo-israeliano, Kurilla ha sempre considerato l’Iran come una minaccia da sradicare. E’ lui che ha voluto e gestito la fallimentare campagna di bombardamenti contro Ansar Allah nello Yemen.
Dietro la determinazione di Kurilla a neutralizzare l’Iran vi è la sua persuasione dell’esistenza di uno stretto legame fra Teheran da un lato, e Mosca e Pechino dall’altro.
Come spiegò alla Commissione delle Forze Armate presso la Camera dei Rappresentanti nel 2023, metà del petrolio e più di un terzo del gas naturale consumato dai cinesi provengono dal Medio Oriente, in gran parte via nave attraverso lo Stretto di Hormuz. “Questo li rende vulnerabili”, concluse Kurilla.
Per lui, dunque, colpire Teheran significava anche indebolire Cina e Russia.
Questa convinzione è condivisa da altri a Washington, in particolare fra repubblicani e neocon. La lobby israeliana ha ovviamente appoggiato l’intera operazione, esercitando pressioni anche su quei democratici che si sono mostrati restii a sostenerla.
Questo vasto fronte ha posto le premesse per un inasprimento delle posizioni negoziali dell’amministrazione, che ha portato la trattativa con Teheran sull’orlo del fallimento, e allo stesso tempo per la pianificazione e l’attuazione dell’attacco.
Chi, in attesa della seconda parte del presente articolo, volesse approfondire questioni legate alla situazione interna iraniana può consultare:
Iran, le proteste di piazza, le ingerenze americane, il contesto internazionale
Chi volesse risalire alle radici storiche della contrapposizione fra Israele e Iran può leggere: