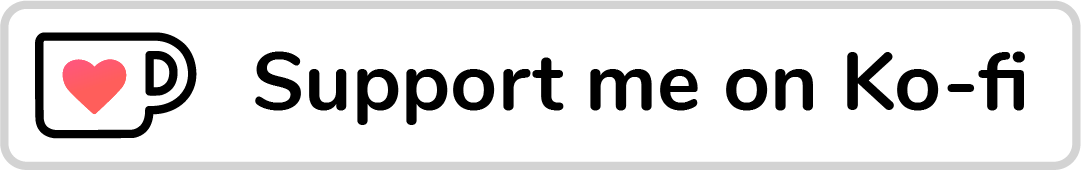Scontro Israele-Iran e rischi di regionalizzazione del conflitto
I missili iraniani nei cieli d’Israele segnano una svolta negli equilibri mediorientali.

Nota per i lettori: l’articolo supera i limiti di lunghezza della mail. Per leggerlo nella sua interezza è sufficiente cliccare sul titolo per aprire la versione completa online.
Come di consueto, molti commentatori occidentali hanno perlopiù travisato, talvolta demonizzato, o perfino deriso, le ragioni e la portata della rappresaglia iraniana compiuta in territorio israeliano.
Essa, facendo emergere la pluriennale “guerra ombra” fra Israele e Iran, finora combattuta prevalentemente “per procura” attraverso una pletora di attori regionali, e trasformandola per la prima volta in un confronto militare diretto, segna nondimeno una pericolosa svolta negli equilibri mediorientali.
Dopo alcuni giorni di attesa, la risposta più volte ventilata dal governo Netanyahu, ma scoraggiata da Washington, è giunta stanotte sotto forma di un attacco limitato, compiuto da piccoli droni (quadricotteri) contro la base militare di Isfahan.
Un episodio che non sembra aver provocato danni (i quadricotteri sono stati abbattuti), e parrebbe un segnale di de-escalation, se non vi saranno altri attacchi nei prossimi giorni (maggiori dettagli più in basso nell’articolo).
La possibilità di uno scontro diretto fra Israele e Iran è però ora una realtà regionale con cui bisogna fare i conti.
Gaza come chiave di volta
La rappresaglia iraniana, consumatasi la notte fra sabato 13 e domenica 14 aprile in conseguenza del precedente bombardamento israeliano del consolato iraniano a Damasco, non rappresenta semplicemente un inedito capitolo del confronto regionale fra Israele e Iran.
Essa è infatti diretta conseguenza della violentissima e sanguinosa operazione militare israeliana, in corso ormai da più di sei mesi e mezzo a Gaza, provocata dall’attacco di Hamas del 7 ottobre.
E’ quella data che segna un vero spartiacque negli eventi mediorientali. La fulminea incursione del gruppo islamico palestinese in territorio israeliano colse di sorpresa avversari ed alleati. La successiva azione militare israeliana ha avuto un effetto dirompente, a livello emotivo, politico e militare, sull’intera regione.
Essa ha inferto una terribile spallata a equilibri regionali cronicamente fragili, portando fin da subito a uno strisciante allargamento del conflitto, che ha coinvolto il cosiddetto asse filoiraniano di cui Hamas è parte integrante.
Iran e palestinesi, due attori marginalizzati
Vi è un legame che unisce la marginalizzazione regionale dell’Iran e la progressiva liquidazione della questione palestinese, il quale rappresenta una chiave di lettura essenziale per comprendere le ragioni dell’attacco del 7 ottobre e gli eventi che ne sono derivati.
La Repubblica Islamica iraniana, sorta dalla rivoluzione che nel 1979 detronizzò lo scià Mohammad Reza Pahlavi, si ritrovò sotto embargo internazionale fin dalla sua fondazione per aver rovesciato una monarchia “amica” dell’Occidente, e aver posto fine all’egemonia anglo-americana nel paese.
L’isolamento del nuovo Stato guidato dall’ayatollah Ruhollah Khomeini era totale anche a livello regionale, poiché i paesi arabi limitrofi temevano un possibile “contagio” della rivoluzione islamica.
L’Iran subì poi il terribile trauma della guerra Iran-Iraq, provocata dall’invasione di Saddam Hussein, sostenuto dai paesi occidentali e da molti Stati regionali. Il sanguinoso conflitto si protrasse fino al 1988.
Teheran fu poi esclusa, per volere del presidente americano Bill Clinton, dal processo di pace israelo-palestinese avviato dagli accordi di Oslo del 1993.
Dal canto suo, il premier israeliano Yitzhak Rabin aveva deciso di abbandonare la “dottrina della periferia” (che si fondava sull’instaurazione di alleanze con le potenze non arabe della regione – Turchia, Etiopia, e lo stesso Iran sotto la dinastia Pahlavi) in favore di una riconciliazione con i vicini arabi. Egli vedeva nell’Iran degli ayatollah un pericoloso avversario regionale.
Asse della Resistenza
Teheran dovette poi confrontarsi con la politica di “esportazione della democrazia” promossa in Medio Oriente da George W. Bush dopo il 2001. Quest’ultimo inserì l’Iran nel cosiddetto “asse del male”, insieme a Iraq e Corea del Nord, paesi che avrebbero dovuto essere “liberati” dai loro regimi autoritari.
L’allora premier israeliano Ariel Sharon, dal canto suo, aderì alla campagna dei neocon americani, esercitando pressioni su Washington riguardo alla necessità di rispondere alla “minaccia” rappresentata dal programma nucleare iraniano.
Quest’ultimo, in realtà già avviato dallo scià, rappresentava la risposta della Repubblica Islamica al trauma delle armi chimiche usate indiscriminatamente da Saddam durante la guerra Iran-Iraq. Teheran, tuttavia, non puntò mai a sviluppare apertamente un’arma atomica, quanto piuttosto a divenire una potenza nucleare “latente”.
L’Iran reagì in maniera asimmetrica all’ostilità israelo-americana, e in particolare alla strategia di “accerchiamento regionale” di Bush, cercando di proiettare la propria influenza a livello mediorientale attraverso alleanze con governi e attori non-statuali che condividevano con Teheran l’avversione all’egemonia di Washington e Tel Aviv.
Venne così a costituirsi progressivamente un asse della “resistenza” filoiraniano a livello regionale, costituito da Hezbollah (nato nel 1982 in Libano, proprio con l’aiuto di Teheran, a seguito dell’invasione israeliana di quel paese), da Hamas (soprattutto a partire dalla sua vittoria elettorale del 2006 e dall’assedio a cui esso fu sottoposto a Gaza a partire dall’anno successivo), dal regime di Damasco, dalle milizie sciite irachene (formatesi paradossalmente proprio a seguito del rovesciamento di Saddam da parte americana), e successivamente dal movimento Ansar Allah (noto anche come Houthi) nello Yemen.
7 ottobre, lo spartiacque
L’insediamento, nel dicembre 2022, dell’ultimo governo Netanyahu, composto da esponenti radicalmente antipalestinesi, e il progetto americano di giungere a una normalizzazione dei rapporti fra Arabia Saudita e Israele, con la prospettiva di una definitiva liquidazione della già lungamente marginalizzata questione palestinese, rappresentano le due scintille che probabilmente hanno spinto Hamas a compiere il sanguinoso quanto disperato attacco del 7 ottobre.
La normalizzazione dei rapporti fra Riyadh e Tel Aviv, sulla scia degli Accordi di Abramo fra Israele e paesi arabi promossi dal presidente americano Trump già a partire dal 2020, rappresentava a sua volta l’ennesimo progetto volto a determinare il definitivo isolamento regionale dell’Iran.
Malgrado le lodi rivolte da Teheran a Hamas per l’operazione del 7 ottobre, definita un successo della resistenza all’occupazione israeliana, la durissima reazione militare di Tel Aviv ha messo l’asse filoiraniano sulla difensiva.
L’obiettivo dichiarato del governo Netanyahu di annientare militarmente e politicamente Hamas ha posto Teheran e i suoi alleati di fronte alla prospettiva di perdere un anello fondamentale dell’asse della resistenza.
Sia Hezbollah, sia le milizie sciite in Iraq e Siria, sia Ansar Allah nel Mar Rosso, hanno intrapreso azioni militari contro Israele e gli Stati Uniti in segno di solidarietà con Hamas.
Israele cambia le “regole del gioco”
Tuttavia, né Hezbollah né Teheran, i due membri di gran lunga più influenti di questo schieramento, si sono mostrati disposti a scendere in un conflitto aperto con Israele per soccorrere l’alleato di Gaza.
Come ho scritto in un precedente articolo, fino al bombardamento israeliano del consolato iraniano il 1° aprile a Damasco, l’Iran aveva mostrato chiaramente di non volere un allargamento del conflitto:
Teheran ha esercitato pressioni sulle milizie sciite irachene affinché cessassero i propri attacchi contro le basi USA in Siria e Iraq, ed esortato Hezbollah a non fornire alibi a Israele per lanciare una guerra su vasta scala in Libano, ammonendo l’alleato libanese che avrebbe dovuto combattere per proprio conto se un simile conflitto fosse scoppiato.
L’attacco israeliano al consolato, in cui è rimasto ucciso un personaggio chiave come Mohammed Reza Zahedi, generale della Guardia Rivoluzionaria e anello di collegamento fra l’Iran e Hezbollah in Libano, ha posto Teheran di fronte a un dilemma di difficile soluzione.
L’azione israeliana ha rappresentato il culmine di una serie di attacchi sempre più “sfrontati” contro l’asse filoiraniano, ed in particolare contro l’Iran, che hanno portato in rapida sequenza all’uccisione del generale iraniano Radhi Mousavi lo scorso 25 dicembre a Damasco, di Saleh al-Arouri (esponente chiave di Hamas) il 2 gennaio a Beirut, di numerosi esponenti di Hezbollah in Libano e Siria, e di altri membri della Guardia Rivoluzionaria in Siria nei mesi successivi.
Israele stava dunque imponendo nuove “regole del gioco” nello scontro con l’asse filoiraniano, in base alle quali le forze israeliane potevano infliggere colpi sempre più duri a Hezbollah e all’Iran senza attendersi rappresaglie significative perché questi ultimi volevano evitare un’escalation militare.
Una rappresaglia preannunciata
Il bombardamento del consolato di Damasco, una rappresentanza diplomatica, e l’uccisione del generale Zahedi, hanno costituito un ulteriore salto di qualità negli attacchi israeliani, di fronte al quale Teheran ha ritenuto di essere obbligata a reagire per ristabilire un livello minimo di deterrenza nei confronti di Tel Aviv.
Per di più, il 3 aprile (due giorni dopo l’attacco al consolato) Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia si sono opposti a una dichiarazione di condanna dell’episodio da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
L’11 aprile, la missione iraniana presso le Nazioni Unite ha dichiarato che, se il Consiglio di Sicurezza avesse condannato l’atto di aggressione israeliano, Teheran avrebbe potuto soprassedere alla necessità di “punire” Israele.
Fin da subito l’Iran aveva comunicato a Washington – tramite l’incaricato d’affari dell’Ambasciata svizzera che rappresenta gli interessi americani a Teheran – che una rappresaglia iraniana era imminente, ammonendo gli USA a non intervenire in modo da evitare un’ulteriore escalation.
Ciò ha permesso a Israele ed ai suoi alleati di preparare minuziosamente le contromisure difensive per un attacco ampiamente atteso. Anche i paesi limitrofi sono stati esplicitamente preavvertiti da Teheran, ricevendo assicurazioni che l’Iran non intendeva andare oltre quella singola azione di rappresaglia.
Fonti iraniane hanno dichiarato di aver informato gli USA, attraverso canali diplomatici che hanno incluso Qatar, Turchia e Svizzera, sul giorno dell’attacco, e che quest’ultimo sarebbe stato condotto in maniera tale da evitare di provocare una risposta.
La notte dell’attacco
La rappresaglia è cominciata la notte del 13 aprile, allorché la Guardia Rivoluzionaria ha lanciato (secondo la versione diffusa dai media occidentali) 185 droni, seguiti da 36 missili da crociera e successivamente da 110 missili balistici a medio raggio.
L’attacco si è protratto per diverse ore (a causa del fatto che i droni, i primi a essere lanciati, sono lenti e dunque impiegano molto tempo per raggiungere gli obiettivi).
Nel frattempo, la missione iraniana all’ONU motivava l’operazione invocando l’articolo 51 della Carta dell’ONU, che riconosce il diritto all’autodifesa di fronte a un attacco armato, “dopo un periodo di 13 giorni segnato dall’inazione e dal silenzio del Consiglio di Sicurezza, accompagnati dalla sua incapacità di condannare le aggressioni del regime israeliano”.
Al termine dell’operazione, conclusasi senza particolari incidenti, la missione iraniana comunicava che per Teheran la questione poteva “considerarsi conclusa”. Essa tuttavia ammoniva che, se Israele avesse commesso un altro “errore”, la risposta dell’Iran sarebbe stata “considerevolmente più severa”. Il messaggio si chiudeva chiarendo che questo era un conflitto fra Teheran e Tel Aviv, dal quale gli USA dovevano “tenersi alla larga”.
I paesi occidentali hanno a loro volta duramente condannato l’azione di Teheran, senza tuttavia menzionare il precedente attacco di Tel Aviv al consolato iraniano di Damasco.
L’attacco è stato definito un fallimento dai media occidentali di grande diffusione. Il portavoce dell’esercito israeliano ha dichiarato che il 99% dei missili e dei droni lanciati dall’Iran erano stati intercettati dalle difese israeliane.
Il presidente americano Biden ha salutato la “notevole capacità” israeliana di difendersi da simili “attacchi senza precedenti”, dimostrando ai suoi avversari che “non possono realmente minacciare la sicurezza di Israele”.
Guerra nei cieli israeliani
La rappresaglia iraniana è stata in effetti un’azione “telefonata”, ovvero ampiamente preannunciata per permettere a Israele ed ai suoi alleati di prepararsi, ed è stata attentamente calcolata per minimizzare il rischio di vittime, prendendo di mira soltanto obiettivi militari (ben protetti e precedentemente evacuati).
In questo senso, quella iraniana è stata un’azione dimostrativa, volta a ristabilire un livello di deterrenza nei confronti di Israele, e non a provocare una guerra. Essa non è stata però né un fallimento militare, né un’operazione meramente simbolica.
Teheran ha portato la guerra nei cieli israeliani, con un attacco di una scala e una portata che non hanno niente a che vedere con ciò che Israele aveva conosciuto fino a quel momento: i razzi di Hamas. Lo spettacolo nei cieli israeliani è stato impressionante, e l’impatto psicologico senz’altro enorme.
Lo conferma il fatto che, in previsione del possibile attacco, il premier Netanyahu era stato ospitato per il fine settimana dal magnate Simon Falic a Gerusalemme, la cui abitazione è dotata di un bunker fortificato.
Per difendersi, Israele si è avvalso non solo del proprio sofisticato sistema di difesa aerea, composto da molteplici livelli di protezione (Iron Dome, David’s Sling, Arrow), ma da una rete alleata costituita da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Giordania, i cui aerei e sistemi di difesa schierati nella regione hanno abbattuto gran parte dei droni e dei vettori missilistici già negli spazi aerei di Iraq e Giordania.
Malgrado ciò, decine di missili sono giunti nei cieli israeliani, e almeno 9 di essi hanno “bucato” anche il denso sistema di difesa dell’esercito di Tel Aviv colpendo le basi militari di Ramon e Nevatim, nel sud di Israele, secondo fonti USA.
I danni causati sono stati (forse volutamente) abbastanza limitati, secondo tali fonti (danneggiati alcuni depositi, un aereo da trasporto C-130, una pista di atterraggio).
Per bloccare l’azione iraniana, il sistema di difesa aerea di Tel Aviv ha impiegato un numero impressionante di intercettori (un singolo missile intercettore del sistema Arrow costa 3,5 milioni di dollari), per una spesa complessiva superiore al miliardo di dollari, secondo fonti israeliane.
Sebbene l’attacco iraniano sia stato massiccio – organizzato similmente a quelli compiuti dai russi in Ucraina, ma ben più robusto, per battere un sistema di difesa integrato molto più solido di quello di Kiev – Teheran ha impiegato solo una frazione del suo arsenale missilistico e di droni.
La potenza missilistica iraniana
Secondo alcune stime USA, l’Iran possiede decine di migliaia di droni, e almeno 3.000 missili balistici (a cui vanno aggiunti i missili da crociera). Ma il numero reale di questi vettori potrebbe ammontare anche al doppio, essendo sempre difficile stimare l’arsenale di un avversario che compie ogni sforzo per celare il proprio reale potenziale.
Questa dotazione è conseguenza del fatto che Teheran, non potendo disporre di una moderna aviazione militare a causa del pluriennale embargo a cui è sottoposta, ha optato per droni e missili, più facili da sviluppare in proprio rispetto a caccia e bombardieri.
L’Iran è perciò divenuta una potenza missilistica a livello regionale, anche se va ricordato che le spese militari iraniane hanno recentemente oscillato intorno ai 10 miliardi di dollari l’anno. Una cifra irrisoria rispetto alle spese saudite, e notevolmente inferiore anche al bilancio militare di Israele (che per di più usufruisce degli aiuti statunitensi).
Il fatto che l’Iran abbia lanciato un numero limitato di missili, utilizzando vecchie varianti e non le sue armi di ultima generazione, conferma che l’intento della rappresaglia era dimostrativo.
Benché la versione ufficiale occidentale abbia descritto l’intercettazione dei missili iraniani come un’operazione di grande successo, gli esperti militari occidentali sanno bene che l’azione di Teheran ha mostrato che Israele è vulnerabile.
Il giorno dopo l’attacco, Biden ha detto a Netanyahu di tenersi la sua “vittoria”, e che gli USA non avrebbero preso parte a un’eventuale risposta israeliana.
Nei giorni seguenti, l’amministrazione americana ha continuato a “scoraggiare” il governo Netanyahu dal rispondere con un’azione in territorio iraniano, sottolineando che l’Iran avrebbe certamente reagito a sua volta, innescando un’escalation, e che gli sforzi per difendere Israele da ulteriori attacchi avrebbero potuto registrare esiti “meno positivi” rispetto a quelli di domenica 14 aprile.
Il dilemma strategico di Israele
La situazione è rimasta tuttavia estremamente tesa. La rappresaglia di Teheran ha costituito il primo attacco mai sferrato a Israele direttamente dal territorio iraniano. Un’azione che il governo Netanyahu non voleva lasciare “impunita”.
I vertici israeliani, tradizionalmente ossessionati dal concetto di “deterrenza”, ritenevano che già l’aggressione di Hamas del 7 ottobre avesse indebolito la credibilità militare di Israele, che pertanto poteva essere ristabilita solo con l’annientamento del gruppo palestinese.
La rappresaglia iraniana ha ulteriormente “esposto” le vulnerabilità di Israele, e ciò, dal punto di vista di Tel Aviv, richiedeva di ristabilire il potere di deterrenza perduto.
Il dilemma strategico israeliano è conseguenza della scelta di aver sempre puntato sulla deterrenza, e quindi sulla supremazia militare, come unico strumento per garantire la sicurezza dello Stato ebraico. Ciò vale sia all’interno, nei confronti dei palestinesi, sia a livello degli altri paesi della regione.
La possibilità di pervenire a una forma di convivenza regionale attraverso una soluzione della questione palestinese è stata invece scartata praticamente da tutti i governi israeliani. Ma ciò non ha fatto altro che moltiplicare i nemici di Israele.
Con il suo attacco al consolato iraniano a Damasco, il governo Netanyahu ha peraltro dimostrato di non saper valutare correttamente il carattere destabilizzante delle proprie sfrontate azioni militari a livello regionale.
Quell’attacco ha provocato frizioni con gli stessi americani, i quali hanno accusato il loro alleato di aver messo a rischio la sicurezza delle truppe USA nella regione con un’operazione che Tel Aviv non aveva comunicato in anticipo a Washington.
Salvare la faccia
Secondo fonti sia israeliane che americane, da domenica scorsa per due volte i vertici israeliani hanno preso la decisione di rispondere alla rappresaglia di Teheran e sono stati fermati all’ultimo momento dall’amministrazione Biden.
Infine è giunta, nelle ultime ore, la notizia di un attacco compiuto questa notte da Israele contro una base militare iraniana a Isfahan. Tuttavia è subito emerso che si era trattato di un’operazione contenuta, di nessun impatto militare.
Sebbene alcuni quotidiani occidentali abbiano parlato di attacchi aerei, non vi è alcuna conferma in questo senso. Fonti iraniane hanno descritto un’azione compiuta da piccoli droni (quadricotteri), forse decollati dallo stesso territorio iraniano, e abbattuti dalla contraerea.
Episodi del genere si sono già verificati in passato (Israele ha contatti e infiltrazioni locali che possono condurre simili attacchi di scala ridotta).
Il Jerusalem Post ha parlato di missili “aviolanciati” i cui resti sono stati però ritrovati in Iraq, nel qual caso si sarebbe trattato di un mero lancio dimostrativo.
Il segretario di Stato USA Antony Blinken si è ripetutamente rifiutato di confermare l’attacco israeliano, dichiarando soltanto che Washington non è coinvolta in alcuna operazione offensiva, ed è invece impegnata a ridurre le tensioni nella regione.
L’episodio potrebbe dunque chiudere almeno temporaneamente i conti fra Israele e Iran, sebbene lo scontro a livello regionale sia destinato a continuare.
Washington umiliata dal resto del mondo
Nel frattempo, gli USA hanno dovuto ingoiare un’altra umiliazione. L’iniziativa della loro missione diplomatica all’ONU, volta ad emettere un comunicato congiunto di condanna nei confronti dell’Iran per il suo “attacco allo Stato di Israele”, si è risolto in un fiasco.
Al di fuori dell’Occidente, essa ha raccolto l’adesione dell’Argentina di Javier Milei, dell’Ecuador, della Corea del Sud, della Micronesia, di Palau e della Papua Nuova Guinea. L’intera Africa, e gran parte del continente asiatico (inclusa la Turchia, un membro della NATO) hanno declinato l’invito.
Al Consiglio di Sicurezza, Russia e Cina hanno sostenuto le ragioni dell’Iran. Ad eccezione dell’Occidente, dunque, il resto del mondo ritiene che Teheran abbia legittimamente risposto ad una palese violazione del diritto internazionale da parte di Israele.
La Casa Bianca ha enormi responsabilità per aver lasciato che la disastrosa guerra di Gaza esercitasse per mesi il suo effetto destabilizzante sull’intera regione. Biden ha praticamente dato carta bianca a Netanyahu, sostenendolo con un ininterrotto flusso di armi.
La sua amministrazione non ha posto alcun freno alla violentissima azione militare israeliana, che ha provocato la morte di 34.000 palestinesi e la totale distruzione della Striscia. E non ha chiesto a Israele di moderare i propri bombardamenti e i propri omicidi mirati in Libano e Siria, sebbene sia Hezbollah che Teheran avessero mostrato di non volere un allargamento del conflitto.
La Casa Bianca ha coltivato l’illusione che la catastrofe di Gaza potesse trascinarsi indefinitamente, e che fosse possibile contenerne le ripercussioni regionali con meri ammonimenti e con il rafforzamento della presenza militare USA nella regione.
L’ostinazione americana ad esercitare un’egemonia ormai logora, che non sa offrire soluzioni né pacificazioni reali, sta spingendo la regione verso il baratro.