Viaggio alle origini della rivalità fra Israele e Iran
Gli eventi che hanno portato alla fusione di due questioni relativamente distinte, seppur legate dalla comune lotta anticoloniale: il conflitto israelo-palestinese e la questione iraniana.

Il conflitto seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, all’inizio confinato principalmente a Gaza, si è progressivamente esteso al Libano, allo Yemen ed al Mar Rosso, alla Siria e all’Iraq.
In questo contesto, la rivalità fra Israele e Iran, per anni manifestatasi come uno confronto indiretto e combattuto “per procura” su numerosi teatri mediorientali, sta sfociando in un pericoloso scontro diretto fra i due paesi, che potrebbe coinvolgere gli Stati Uniti e far deflagrare l’intera regione.
A prescindere dalla crescente espansione ed intensificazione delle operazioni belliche nei teatri sopra citati, è stata la campagna israeliana di omicidi mirati a danno di esponenti di spicco del cosiddetto “asse della resistenza” filo-iraniano a provocare per la prima volta risposte dirette contro Israele da parte di Teheran.
Com’è noto, tale asse include Hamas e la Jihad Islamica in Palestina, Hezbollah in Libano, la Siria del presidente Bashar al-Assad, diverse milizie sciite in Iraq, il gruppo Ansar Allah (meglio noto come gli “Houthi”) nello Yemen, e naturalmente l’Iran.
Due episodi, in particolare, hanno rappresentato altrettanti punti di svolta in questa contrapposizione: il bombardamento israeliano del consolato iraniano a Damasco lo scorso 1° aprile, e quello violentissimo sulla Dahiya (il sobborgo meridionale) di Beirut del 27 settembre.
Nel primo sono rimasti uccisi tre generali della forza Quds della Guardia Rivoluzionaria iraniana (IRGC, secondo l’acronimo inglese). Il secondo ha eliminato fisicamente Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah, insieme ad alcuni dirigenti del gruppo e ad un altro generale iraniano.
Entrambi questi attacchi hanno provocato una risposta missilistica iraniana diretta contro il territorio israeliano, evento mai verificatosi prima nella storia dei due paesi. La prima rappresaglia si è consumata nella notte fra il 13 e il 14 aprile, la seconda, militarmente più incisiva, in quella del 1° ottobre.
Secondo dichiarazioni ufficiali iraniane, il secondo attacco è avvenuto per replicare non solo al bombardamento di Beirut del 27 settembre, ma anche all’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh compiuto da Israele lo scorso 31 luglio a Teheran, al quale l’Iran non aveva fino a quel momento risposto.
Alla prima rappresaglia iraniana Israele ha reagito con un’operazione molto limitata, probabilmente condotta con piccoli droni, in territorio iraniano. Alla seconda, con un attacco tramite droni e missili balistici aviolanciati che ha causato danni relativi ai sistemi di difesa aerea iraniani e ad alcuni impianti della produzione missilistica del paese.
Teheran, mentre ha ignorato la prima operazione, ha dichiarato che non avrebbe lasciato impunita la seconda. Ciò ha spinto Washington ad inviare nuove forze aeree e navali nella regione a difesa di Israele nel caso di un ulteriore attacco iraniano, facendo così temere un’escalation potenzialmente in grado di sfuggire di mano.
Questa situazione così pericolosa è storicamente conseguenza della fusione a livello regionale di due questioni relativamente distinte, seppur legate dalla comune lotta anticoloniale: il conflitto israelo-palestinese e la questione iraniana.
La mancata risoluzione delle due questioni, e l’evoluzione dei conflitti regionali che vedono coinvolti in diversa misura Iran, Israele, e Stati Uniti, hanno portato al progressivo coagularsi delle forze che si oppongono all’egemonia israelo-americana nella regione, dando vita al già citato “asse della resistenza”.
I due leader regionali di questi schieramenti contrapposti, Israele e l’Iran, sono entrati gradualmente in rotta di collisione, un processo che ha subito un’accelerazione impressionante dopo gli eventi del 7 ottobre.
Le radici dell’inimicizia tra Iran e Occidente
La questione iraniana, come quella israelo-palestinese, trae origine da eventi risalenti alla fine del XIX secolo. In quel periodo la Persia rimase coinvolta nello scontro asiatico tra la Russia zarista e l’impero coloniale inglese, anche a causa della sua posizione geografica adiacente all’India britannica.
Durante la rivoluzione costituzionale iniziata nel 1905, la Persia assistette alla nascita del suo primo parlamento (majlis) e alla creazione di una monarchia costituzionale, ma anche alla suddivisione del paese in una zona d’influenza russa al nord ed una d’influenza britannica al sud.
Sia inglesi che russi tramarono contro i costituzionalisti persiani, e durante il primo conflitto mondiale invasero il paese per tenere a bada gli eserciti tedeschi e ottomani.
Dopo la Grande Guerra, mentre i russi erano assorbiti dalla rivoluzione comunista, fu la Gran Bretagna a divenire la potenza dominante in una Persia da tempo ridotta allo stato semicoloniale, ed a sfruttarne abbondantemente le enormi riserve energetiche.
Gli sforzi iraniani per tornare alla piena indipendenza tuttavia non cessarono. Tali sforzi portarono all’elezione del primo ministro nazionalista Mohammad Mosaddegh da parte del majlis nel 1951. Lo Shah Mohammad Reza Pahlavi fu costretto a ratificarne la nomina per la grande popolarità di cui godeva Mosaddegh.
Quest’ultimo, con il sostegno di laici, religiosi e comunisti, procedette alla nazionalizzazione dell’Anglo-Iranian Oil Company, antesignana della British Petroleum (BP). Londra reagì imponendo un boicottaggio internazionale del petrolio iraniano.
La Gran Bretagna inoltre convinse Washington che Mosaddegh avrebbe finito per consegnare l’Iran ai comunisti, permettendo così ai sovietici di avere accesso al Golfo Persico.
La CIA ed il britannico Secret Intelligence Service organizzarono perciò un golpe ai danni di Mosaddegh (la cosiddetta “Operazione Ajax”) riconsegnando il potere allo Shah nell’agosto del 1953.
Com’era già avvenuto durante la rivoluzione costituzionale di inizio secolo, il golpe del 1953 ancora una volta interruppe l’evoluzione democratica dell’Iran.
Il rovesciamento di Mosaddegh, considerato in Iran un eroe nazionale, segnò il culmine della storia di inimicizia fra Iran e Gran Bretagna, e l’inizio di un’altra pericolosa contrapposizione, quella fra iraniani e americani.
Nel frattempo, tuttavia, l’Iran dello Shah Mohammad Reza Pahlavi (il quale impose un’occidentalizzazione forzata del paese con il sostegno di Washington) divenne uno dei pilastri dell’architettura di sicurezza americana nel Golfo, dove l’influenza statunitense aveva rimpiazzato la presenza coloniale britannica.
Il risentimento di molti iraniani nei confronti degli USA tuttavia continuava a crescere, mentre la CIA stringeva rapporti con la SAVAK, la feroce polizia segreta dello Shah, e Washington vendeva armi al suo esercito.
La rivoluzione del 1979, inizialmente manifestatasi come una sollevazione di ampie fasce della popolazione sostenuta da laici, nazionalisti e religiosi contro l’odiato regime della dinastia Pahlavi, vide il culmine di tale sentimento antiamericano.
Sotto la guida del carismatico Ayatollah Ruhollah Khomeini, la rivolta inizialmente composita assunse la connotazione di una rivoluzione islamica. Gli Stati Uniti, colti alla sprovvista, offrirono asilo allo Shah.
Nel clima di ostilità antiamericana che si respirava a Teheran, il personale diplomatico dell’ambasciata USA fu preso in ostaggio da gruppi di studenti iraniani. Esso fu accusato di essere legato alla CIA e di complottare un golpe ai danni della rivoluzione, così come Washington aveva già fatto nel 1953 contro il primo ministro Mosaddegh.
La crisi degli ostaggi si protrasse per 444 giorni, e rappresentò per gli Stati Uniti un affronto che gli americani non avrebbero dimenticato.
Con la nascita della Repubblica Islamica iraniana, crollava anche la dottrina dei “due pilastri” di Nixon che aveva fondato l’egemonia statunitense nella regione del Golfo sull’Iran dei Pahlavi e sull’Arabia Saudita.
Le altre componenti della rivoluzione iraniana furono progressivamente schiacciate. La soppressione della componente comunista, in particolare, fu anche conseguenza dell’appoggio dato da Mosca all’assediato governo filosovietico del vicino Afghanistan, poi culminato con l’invasione del 1979.
A causa dell’amaro ricordo dell’espansionismo russo di inizio secolo, in Iran ciò portò ad una reazione fondamentalista contro le componenti di sinistra della rivoluzione, all’insegna dello slogan “Né Oriente né Occidente: Repubblica Islamica”.
L’opposizione non islamica fu schiacciata anche a seguito di un altro evento traumatico: la decisione del presidente iracheno Saddam Hussein, laico e nazionalista panarabo, di invadere l’Iran nel settembre del 1980.
Temendo il “contagio” della rivoluzione islamica iraniana, le monarchie del Golfo sostennero Saddam con ingenti aiuti durante il conflitto. Quest’ultimo fu appoggiato anche dai paesi occidentali, ed in particolare dagli Stati Uniti che speravano di rovesciare sul nascere la neonata Repubblica Islamica.
L’appoggio americano non cessò neanche quando Washington venne a conoscenza del fatto che Saddam faceva abbondante uso di armi chimiche. Al contrario, gli Stati Uniti lo aiutarono a produrle ed utilizzarle.
Il sanguinoso conflitto si protrasse per ben otto anni, e costò all’Iran centinaia di migliaia di vittime e di invalidi.
Israele e Iran dall’amicizia alla contrapposizione
Fin dal primo momento, la questione palestinese ebbe un ruolo di primo piano nell’ideologia khomeinista alla base della rivoluzione del 1979, sia per ragioni religiose che per la comune appartenenza all’ambito della lotta anticoloniale.
Già dieci anni prima, Khomeini aveva emesso un parere religioso (fatwa) in favore della guerriglia palestinese. Negli anni ’70 Fatah, la fazione dominante nell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), era emerso come un importante snodo del movimento di lotta internazionale contro lo Shah.
Il gruppo palestinese ebbe un ruolo nella nascita dell’IRGC, molti dei cui fondatori si erano addestrati nei campi profughi palestinesi negli anni ’70.
Tuttavia, nel corso degli anni, la spinta ideologica della rivoluzione del ’79 è stata progressivamente temperata dalle necessità dettate dalla situazione iraniana interna e dal contesto regionale. Pur rimanendo generalmente fedeli agli ideali rivoluzionari, i dirigenti iraniani adottarono politiche dettate da un approccio pragmatico e dagli interessi nazionali.
Come ha scritto il ricercatore israeliano Raz Zimmt, posta di fronte alla scelta fra l’impegno ideologico e considerazioni pragmatiche, la leadership iraniana spesso ha dato preferenza a queste ultime.
E’ in questo quadro che bisogna analizzare l’evoluzione della rivalità tra Iran e Israele (due paesi che erano in buoni rapporti sotto la dinastia Pahlavi), la quale si consolidò progressivamente negli anni passando da una mera contrapposizione ideologica ad un vero e proprio conflitto strategico.
Nel 1982, fu l’invasione israeliana del Libano per sradicare l’OLP dal paese ad attirare l’intervento iraniano a sostegno della resistenza palestinese e libanese.
Tale intervento, che avrebbe portato alla nascita di Hezbollah, fu motivato non solo dai legami transnazionali di lotta anticoloniale esistenti tra il movimento rivoluzionario iraniano e quello di liberazione palestinese, ma dai rapporti secolari esistenti fra lo sciismo libanese e quello iraniano.
Hezbollah avrebbe scacciato l’esercito israeliano da Beirut e da gran parte del territorio libanese (ad esclusione del sud del paese) entro il 1985.
Il comune timore nei confronti delle ambizioni regionali di Saddam Hussein (che in quel momento era in guerra con l’Iran) e della possibilità che il Libano cadesse nel campo d’influenza di Egitto e Giordania, i quali avevano riconosciuto Israele ed erano divenuti alleati degli Stati Uniti, contribuì anche a cementare l’alleanza fra Iran e Siria.
La cooperazione fra Teheran e Damasco nel fornire armi, addestramento, ed una retrovia strategica a Hezbollah permise a quest’ultimo di liberare tutto il territorio libanese dalla presenza militare israeliana entro il 2000 (ad eccezione della Fattorie di Shebaa, nelle alture del Golan).
Esclusione iraniana dal processo di pace regionale
Ancora negli anni ’80, tuttavia, la contrapposizione fra Iran e Israele non era esistenziale, tanto che Tel Aviv fornì armi americane a Teheran nell’ambito del cosiddetto “scandalo Iran-Contras” (i proventi di tali armi servirono agli USA per finanziare l’opposizione armata dei Contras contro il movimento sandinista in Nicaragua).
Come scrissi in un precedente articolo, la crescente rivalità fra Iran e Israele fu conseguenza
dei nuovi equilibri regionali emersi dopo il crollo dell’Unione Sovietica, ed in particolare del progressivo smantellamento del regime iracheno di Saddam Hussein a partire dal 1991.
In precedenza, la leadership panaraba di Saddam aveva fatto dell’Iraq un nemico sia di Israele che dell’Iran, ma anche l’ago della bilancia degli equilibri regionali, e una barriera di fatto tra lo Stato ebraico e la Repubblica Islamica.
Dopo la guerra del Golfo del ’91 l’amministrazione Clinton impose un embargo durissimo nei confronti del regime di Saddam, ed inasprì quello nei confronti dell’Iran, in base alla nuova politica del “doppio contenimento” nei confronti dei due paesi.
In base a questa stessa politica, Bill Clinton escluse entrambi i paesi dalla conferenza di Madrid del 1991 che avrebbe posto le basi del processo di pace israelo-palestinese, avviato due anni dopo dagli accordi di Oslo.
La scelta americana coincise con una rivoluzione strategica da parte israeliana. Tra gli anni ’50 e ’60, Israele aveva elaborato una strategia delle “alleanze periferiche” che puntava a controbilanciare la minaccia rappresentata dai paesi arabi vicini ostili stringendo rapporti con paesi non arabi come Iran, Turchia ed Etiopia.
Parallelamente, il primo ministro israeliano David Ben-Gurion aveva concepito l’idea di una “alleanza delle minoranze”, in riferimento a gruppi etnici non arabi e minoranze religiose della regione come curdi, drusi, cristiani maroniti, ecc..
Lo scopo era di fomentare le aspirazioni nazionaliste delle minoranze allo scopo di frammentare il mondo arabo, creando delle “isole” di alleati in un “oceano” di nazionalismo arabo.
In questo contesto, l’Iran della dinastia Pahlavi era stato un partner naturale di Israele. Non lo fu più la Repubblica Islamica dopo il 1979.
All’inizio degli anni ’90, il premier israeliano Yitzhak Rabin decise di porre in secondo piano la strategia delle alleanze periferiche, concentrandosi invece su un processo di riconciliazione con i vicini arabi nel quadro del processo di pace israelo-palestinese.
Teheran, esclusa dalla conferenza di Madrid e dal processo di riconciliazione arabo-israeliano, ed emarginata dall’architettura di sicurezza americana nella regione, cominciò a stringere rapporti con quelle fazioni palestinesi – Hamas e la Jihad Islamica – che avevano rifiutato gli accordi di Oslo ritenendoli una resa nei confronti di Israele.
Fu in questo quadro che Iran ed Israele cominciarono a considerarsi reciprocamente come i due principali rivali nella regione.
Le guerre dei neocon e di Israele
Con l’ascesa della fazione dei neocon a Washington alla fine degli anni ’90, Washington abbandonò la teoria del doppio contenimento in Medio Oriente a favore della dottrina del “cambio di regime”, a partire dall’Iraq.
L’arrivo alla Casa Bianca di George W. Bush e gli eventi dell’11 settembre permisero a questa fazione radicale di plasmare la politica statunitense nella regione mediorientale, segnando una convergenza senza precedenti fra le posizioni di Washington e le linee più intransigenti della politica estera israeliana.
I neocon ritenevano che gli interessi americani e la sicurezza di Israele sarebbero stati assicurati da una serie di “cambi di regime” nei paesi della regione, da realizzare attraverso una sorta di “guerra permanente”.
Nel suo discorso sullo “stato dell’Unione” del gennaio 2002, Bush inserì l’Iran nel cosiddetto “asse del male” insieme a Iraq e Corea del Nord, accusando la Repubblica Islamica di puntare alla costruzione di armi di distruzione di massa e di esportare il terrorismo.
Il riferimento, fra l’altro, era al programma nucleare riavviato dal successore di Khomeini, l’ayatollah Ali Khamenei, all’indomani della traumatica esperienza della guerra con l’Iraq e del pesante ricorso alle armi chimiche da parte di Saddam.
Tale programma era stato originariamente iniziato dallo Shah con la collaborazione americana, e poi sospeso dopo la rivoluzione del ’79.
A tale proposito va rilevato che l’Iran ha comunque continuato ad aderire al Trattato di non-proliferazione nucleare (NPT). Il suo programma nucleare è pertanto rimasto sotto il monitoraggio dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).
Le tensioni fra USA e Iran crebbero drammaticamente negli anni seguenti. Il ritornello della “esportazione della democrazia” e del “cambio di regime” sarebbe riecheggiato in tutto il mondo arabo, dall’invasione americana dell’Iraq nel 2003 alla guerra israeliana in Libano del 2006, descritta dall’allora segretario di Stato Condoleezza Rice come “i dolori del parto del nuovo Medio Oriente”.
Israele abbracciò pienamente la politica del “regime change” adottata dall’amministrazione Bush, al punto che l’allora primo ministro israeliano Ariel Sharon dichiarò a una delegazione del Congresso USA, alla vigilia della campagna irachena del 2003, che successivamente sarebbe venuto il turno dell’Iran, della Libia e della Siria.
Teheran reagì cercando di proiettare la propria influenza in tutto il Medio Oriente attraverso partiti, movimenti e gruppi armati alleati – da Hezbollah in Libano, a Hamas in Palestina, alle milizie sciite irachene – con l’obiettivo di rompere l’assedio di Washington sostenuto da Israele e dai partner arabi degli USA.
Come scrissi in precedenza, nell’estate del 2006
il conflitto fra Israele e Hezbollah segnò per quest’ultimo, e per il suo leader Hassan Nasrallah, un picco di popolarità fra le masse arabe.
Mentre regimi come quello egiziano e quello saudita disprezzavano il partito sciita libanese, considerandolo una pedina nelle mani dell’Iran, agli occhi delle popolazioni arabe sia Hezbollah che Hamas erano paladini della questione palestinese e della “resistenza” contro l’occupazione israeliana.
Le devastanti quanto inconcludenti guerre israelo-americane dell’era Bush, terminate con l’invasione israeliana di Gaza a cavallo fra il 2008 e il 2009, avevano rafforzato l’influenza della Repubblica Islamica, divenuta un attore essenziale nel conflitto arabo-israeliano di pari passo con il declino dei regimi arabi e con il tramonto del loro ruolo a sostegno della questione palestinese.
Si delineò così quell’assetto regionale che, malgrado sviluppi successivi come le rivolte arabe del 2011, la guerra civile in Siria (nella quale Iran e Israele si sarebbero ulteriormente scontrati in territorio siriano), e gli Accordi di Abramo fra Israele ed alcuni paesi arabi promossi da Donald Trump nel 2020, è rimasto fondamentalmente inalterato fino al 7 ottobre 2023, la scintilla che ha scatenato l’attuale conflitto.
E’ questo assetto, il quale vede l’asse israelo-americano nella regione contrapposto a un “asse della resistenza” filo-iraniano che si estende dalla Palestina al Libano, alla Siria e all’Iraq, allo Yemen e all’Iran, ad aver posto le premesse per l’allargamento del conflitto scoppiato a Gaza.
La volontà israeliana di smantellare l’asse iraniano, dapprima puntando alla distruzione di Hamas, e poi a quella di Hezbollah attraverso la decapitazione della leadership del movimento e l’invasione del Libano, ha spinto l’Iran e Israele sull’orlo di uno scontro militare diretto.




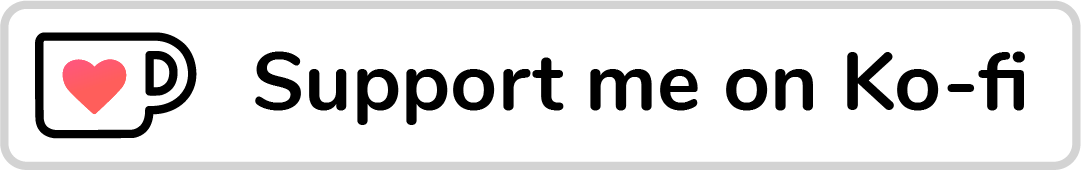
Il martellamento di notizie del presente prende un altro significato tenendo conto della lunga storia delle evoluzioni dell'Iran. Un articolo di grande utilità per chi ha memoria corta o semplicemente manca degli strumenti per informarsi adeguatamente.
Complimenti e grazie
Puntuale e completa analisi della situazione storica nel Medioriente.