Gaza: una catastrofe che può tradursi nella nemesi di USA e Israele
L’ipotesi di un protettorato neocoloniale prende contraddittoriamente forma, ma il vuoto scavato da Washington e Tel Aviv nella regione rischia di trasformarlo in un disastroso fallimento.

L’inizio dell’offensiva israeliana a Rafah apre una nuova tragica pagina nel catastrofico conflitto di Gaza che si protrae ormai da più di 7 mesi. L’offensiva accelera nuovamente uno sterminio che molti hanno definito un genocidio in atto.
Intanto, i rinnovati dissidi fra l’amministrazione Biden e il governo Netanyahu, finora non tali da provocare una vera rottura ma comunque sintomo di un malessere fra i due alleati, sono indicativi del vicolo cieco strategico in cui sia Washington che Tel Aviv stanno sprofondando.
Un possibile futuro assetto di Gaza sta faticosamente emergendo, non per effetto di una pianificazione concertata da parte della Casa Bianca e dei vertici israeliani, ma del caotico e sanguinoso evolversi degli eventi.
Tale evoluzione vede i due alleati sempre più legati a doppio filo nella gestione di una crisi che li pone in crescente difficoltà, progressivamente isolati a livello regionale ed internazionale al di fuori dell’Occidente.
I paesi arabi, per ora, sembrano restii a pagare il conto della ricostruzione, e ancor meno a prendere parte all’amministrazione di un’enclave nella quale Hamas è tutt’altro che debellato e Israele continuerà ad intervenire militarmente ancora per lungo tempo. Ma questa posizione potrebbe cambiare in futuro.
Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha recentemente dichiarato in una conferenza stampa di essere in disaccordo con la prospettiva di istituire un governo militare israeliano a Gaza, sebbene le premesse per un simile scenario siano state poste.
L’infrastruttura della nuova occupazione
In 7 mesi di guerra, l’esercito israeliano ha letteralmente “rimodellato” la Striscia. In primo luogo ha creato una “zona di sicurezza” profonda almeno un chilometro lungo l’intero perimetro di confine, radendo al suolo tutte le abitazioni che vi si trovavano.
Questa fascia è destinata a privare la piccola enclave del 16% del suo territorio, inclusi terreni agricoli vitali per il suo sostentamento.
Ad eccezione di circa 300.000 persone che tuttora vi risiedono, in condizioni al limite della sopravvivenza, l’intera regione settentrionale, dove si trova Gaza City, è stata depopolata.
E’ ormai completata la strada militarizzata che l’esercito ha iniziato a costruire a partire da metà febbraio, la quale taglia in due la Striscia poco più a nord della sua parte mediana.
E’ il Corridoio di Netzarim, così chiamato perché segue in parte il tracciato di una vecchia strada riservata ai coloni dell’omonimo insediamento, prima dell’evacuazione israeliana del 2005.
Lungo circa 7 km, il Corridoio isola completamente Gaza City, dove ai residenti palestinesi è proibito tornare, e dove le forze armate israeliane lasciano entrare solo quantità molto limitate di aiuti per i pochi che vi sono rimasti.
Immagini satellitari mostrano la costruzione di avamposti militari lungo il Corridoio di Netzarim, e di posti di blocco lungo la strada costiera e via Salah Al-Din, che percorre centralmente la Striscia da nord a sud.
Da queste basi partono le incursioni delle forze armate israeliane nel nord e nella zona centrale dell’enclave. Dopo aver completato la distruzione di Khan Yunis, una sola brigata era rimasta a Gaza prima dell’inizio della nuova offensiva su Rafah, proprio con il compito di presidiare il Corridoio.
Più di un milione di sfollati, in gran parte provenienti dal nord della Striscia, si era ammassato in tende di fortuna a Rafah, al confine con l’Egitto, prima che la recente offensiva israeliana li obbligasse nuovamente a fuggire, verso la regione costiera di Al-Mawasi.
Un nuovo accesso dal mare
Nel frattempo gli Stati Uniti, con un’iniziativa a prima vista indipendente, hanno portato a termine la costruzione di un molo temporaneo al largo di Gaza, e di una strada costituita da moduli metallici galleggianti che lo congiunge alla terraferma, per garantire l’afflusso degli aiuti che Israele non fa entrare attraverso i valichi di confine terrestri.
Il progetto, che avrà un costo complessivo di 320 milioni di dollari, presenta problemi logistici, meteorologici, e di sicurezza. Per diverso tempo il completamento dei lavori è stato impedito dal mare grosso.
I soldati americani impegnati nell’operazione, trovandosi in una zona di guerra, sono esposti a potenziali attacchi, sebbene Washington abbia escluso che essi raggiungano la spiaggia, e perfino che operino lungo la strada galleggiante.
La sicurezza a terra sarà garantita dalle forze armate israeliane, che hanno spianato un’ampia area sulla costa per far spazio alla zona di scarico delle merci, demolendo decine di abitazioni. Al largo opereranno invece due navi da guerra USA.
I camion lungo la strada galleggiante dovrebbero essere gestiti da un terzo paese, probabilmente la Gran Bretagna. La distribuzione a terra dovrebbe essere coordinata da un’agenzia ONU, sebbene non sia chiaro quale.
Si dovrebbe partire con 90 camion al giorno, per arrivare poi a 150, un numero in ogni caso del tutto insufficiente a coprire le esigenze umanitarie della Striscia.
Scott Paul, un dirigente dell’Oxfam, ha definito il molo galleggiante americano “una soluzione a un problema che non esiste”, alludendo al fatto che per fare entrare gli aiuti a Gaza sarebbe sufficiente aprire i valichi terrestri.
Tuttavia, essendo ancorato alla terraferma proprio in corrispondenza con il Corridoio di Netzarim, il progetto americano si integra perfettamente con l’infrastruttura militare israeliana volta a controllare la Striscia.
Fornendo una via d’ingresso (e di uscita) dal mare, il molo temporaneo può rappresentare un altro tassello in grado di permettere a Israele di disconnettere l’enclave palestinese dal suo territorio.
Un piano per gestire Gaza
Già a fine febbraio, il governo Netanyahu aveva reso noto un piano per gestire la Striscia a fine conflitto. Esso prevedeva:
1) Completa libertà d’azione dell’esercito israeliano in tutta l’enclave palestinese per impedire il riemergere di “minacce terroristiche”.
2) Il mantenimento della zona cuscinetto lungo il confine “fino a quando sarà necessario per ragioni di sicurezza”.
3) Il pieno controllo del Corridoio Philadelphia – una fascia larga 100 metri che si estende lungo tutti i 14 km del confine con l’Egitto, incluso il valico di Rafah – al fine di impedire il contrabbando sotterraneo fra Gaza e il territorio egiziano.
Per l’amministrazione civile della Striscia il piano prevedeva:
1) Un governo civile e una gestione dell’ordine pubblico, “per quanto possibile” basata su personale locale con esperienza amministrativa.
2) Un programma di “de-radicalizzazione” promosso a livello delle istituzioni sociali, educative e religiose, “per quanto possibile” con l’aiuto e il coinvolgimento di paesi arabi che hanno avuto esperienza con tali programmi.
3) L’inizio della ricostruzione solo dopo il completamento del disarmo di Gaza e dopo l’inizio del “programma di de-radicalizzazione”.
Il piano chiariva infine che Israele si oppone a qualsiasi riconoscimento unilaterale di uno Stato palestinese, e “rifiuta categoricamente ogni diktat internazionale riguardante un accordo permanente con i palestinesi”. Tale accordo, affermava il piano, “sarà raggiunto solo attraverso trattative dirette tra le parti senza precondizioni”.
Negli ultimi mesi, le forze armate israeliane hanno tentato, senza riuscirci, di cooptare i clan familiari di Gaza per creare una struttura amministrativa alternativa a quella di Hamas.
Posizioni divergenti
I ministri centristi del governo Netanyahu hanno invocato la creazione di una “entità palestinese locale” che si assuma la responsabilità dell’amministrazione civile, pur senza nominare esplicitamente l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) o il partito Fatah del presidente Mahmoud Abbas.
L’obiettivo è convincere Egitto, Giordania, ed eventualmente qualche monarchia del Golfo, a supervisionare questa autorità locale insieme a Israele, e a dispiegare le loro truppe a Gaza.
Ma gli arabi si sono mostrati per ora contrari a un simile scenario, temendo di diventare una forza di occupazione al servizio di Israele, e di finire sotto il fuoco di Hamas, tuttora forte nella Striscia.
La Casa Bianca dal canto suo condivide l’idea dei ministri centristi israeliani, ed anzi invoca la creazione di un’autorità direttamente controllata dall’ANP.
Ma il premier Netanyahu si è più volte dichiarato ostile a un ritorno dell’ANP a Gaza, avendo affermato di non voler “passare da un Hamastan a un Fatahstan”. Quello a cui in realtà egli si oppone a tutti i costi è una riunificazione di Gaza e della Cisgiordania sotto un’unica amministrazione palestinese.
La ragione è che tale riunificazione potrebbe riaprire il discorso sulla creazione di uno Stato palestinese, soluzione a cui Netanyahu si è mostrato ostinatamente contrario. Così facendo, tuttavia, egli pone un ostacolo difficilmente superabile alla partecipazione araba alla gestione e alla ricostruzione di Gaza nel dopoguerra.
Il dilemma americano
L’intransigenza del premier israeliano, inoltre, rischia di aggravare l’impasse strategica israeliana ed americana, oltre che la spaccatura con la Casa Bianca.
Quest’ultima condivide con Netanyahu l’intento di distruggere Hamas, ma deve conciliarlo con il suo obiettivo più ampio di un’architettura di sicurezza regionale che includa sia le monarchie arabe che Israele, al fine di isolare l’Iran e sabotare la via della seta cinese.
Tale architettura regionale avrebbe dovuto fondarsi sull’India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), un corridoio volto a promuovere l’integrazione fra il subcontinente indiano, la penisola araba e l’Europa, passando per i porti israeliani.
Il progetto dell’IMEC, presentato al G20 in India lo scorso settembre, prevedeva la normalizzazione dei rapporti fra Israele e Arabia Saudita, sulla scia di quegli Accordi di Abramo sponsorizzati dal presidente americano Trump nel 2020 che avevano determinato l’instaurazione di relazioni diplomatiche fra Israele da un lato, e Bahrein ed Emirati Arabi Uniti (EAU) dall’altro.
Promuovendo l’IMEC e la normalizzazione fra Tel Aviv e Riyadh, l’amministrazione Biden sperava di creare un blocco regionale che avrebbe emarginato l’Iran e posto un argine alla penetrazione economica cinese nella regione.
L’attacco di Hamas del 7 ottobre, la violentissima reazione israeliana, e il conseguente sterminio di palestinesi che si protrae ormai da più di 7 mesi a Gaza, hanno tuttavia posto la Casa Bianca in un dilemma.
Teoricamente, la neutralizzazione di Hamas, il conseguente colpo inferto all’asse filo-iraniano di cui il gruppo palestinese fa parte, e il ridimensionamento dell’Islam politico sostenuto da paesi come Qatar e Turchia nella regione, sono obiettivi condivisi a vario titolo da Israele, dagli USA, e da numerosi paesi arabi, inclusi Egitto, Giordania, EAU e Arabia Saudita.
Ma il categorico rifiuto di Netanyahu di uno Stato palestinese anche solo nominalmente indipendente, e il protrarsi dello massacro di palestinesi a Gaza, creano gravi difficoltà alla Casa Bianca, impedendo la normalizzazione dei rapporti israelo-sauditi, e provocando un crescente problema di ordine pubblico e di stabilità interna agli alleati arabi di Washington (Egitto e Giordania in primis) che fanno fatica a controllare la collera delle loro piazze.
Impasse militare
Il protrarsi delle operazioni militari nella Striscia, e il crescente impegno bellico sul fronte nord contro Hezbollah, hanno inoltre impantanato Israele in una guerra di logoramento per la quale l’esercito di Tel Aviv, composto in gran parte di riservisti, è mal equipaggiato. Tale guerra comporta poi un grave fardello per l’economia del paese.
Le difficoltà israeliane, e la mancata definizione di chiari obiettivi strategici, si riflettono nelle crescenti divisioni tra esercito ed esecutivo, e fra i diversi membri del governo.
Consapevole della difficoltà di giungere ad una vittoria militare definitiva su Hamas, l’amministrazione Biden aveva investito molte energie nel negoziato per il rilascio degli ostaggi e il raggiungimento di un cessate il fuoco, nella speranza di poter poi aprire un processo politico.
Il direttore della CIA William Burns si era impegnato in prima persona in tali negoziati, ma l’offensiva israeliana su Rafah ha ancora una volta scompaginato i piani americani.
Al di là del rinvio di un singolo pacchetto di aiuti militari, tuttavia, la protesta della Casa Bianca è stata ancora una volta molto flebile.
Per questo singolo rinvio, Biden ha dovuto fronteggiare non solo i duri rimproveri del governo Netanyahu, ma la mobilitazione in massa della lobby israeliana negli USA, dell’intero partito repubblicano (che ha addirittura presentato una legge finalizzata a ridurre la capacità del presidente di trattenere gli aiuti militari), e anche di alcuni democratici.
E’ però indicativo che la critica più dura nei confronti di Israele sia giunta dal segretario di Stato Antony Blinken, finora uno dei più instancabili fiancheggiatori del governo Netanyahu, il quale ha affermato che, mentre gli USA lavoravano con i paesi arabi per sviluppare “piani credibili per la sicurezza, la governance, e la ricostruzione” di Gaza, la Casa Bianca non ha visto uno sforzo analogo da parte di Tel Aviv.
Blinken ha aggiunto che la protratta azione militare israeliana rischia di provocare un’altrettanto prolungata rivolta armata guidata dalle tuttora consistenti forze di Hamas, oppure un vuoto colmato dall’anarchia e probabilmente ancora una volta dal gruppo palestinese.
Resilienza di Hamas e catastrofe umanitaria
Per certi versi, una conferma la si è avuta proprio con l’avvio dell’offensiva su Rafah, allorché le forze israeliane si sono inaspettatamente trovate a fronteggiare molteplici attacchi da parte di uomini di Hamas riorganizzatisi nel nord della Striscia, a Gaza City, Jabalia, Zeitoun.
Gli attacchi hanno inflitto diverse perdite agli israeliani, confermando fra l’altro la porosità del Corridoio di Netzarim (anche a causa del fatto che la rete di tunnel del gruppo palestinese è tuttora in gran parte funzionante).
La maggior parte delle forze di Hamas ha intanto lasciato Rafah per Khan Yunis, mentre si moltiplicano le voci secondo cui anche il leader del gruppo, Yahya Sinwar, non sarebbe a Rafah ormai da tempo.
Intanto, però, oltre 600.000 civili palestinesi hanno lasciato la cittadina meridionale della Striscia, mentre 100.000 sono sfollati nella parte settentrionale, in quella che sembra una catastrofe umanitaria senza fine.
Finora, 285 km quadrati dell’enclave, circa il 78% del territorio della Striscia, sono stati sottoposti a ordini di evacuazione da parte dell’esercito israeliano, senza che quest’ultimo si sia avvicinato al suo obiettivo di debellare Hamas.
Perseverando nella sua cieca furia, il governo Netanyahu sta trascinando con sé un’amministrazione Biden imbelle, che da un lato dipende dalle fortissime connivenze israeliane presenti nell’establishment USA, ma dall’altro deve fare i conti con il crescente malcontento della base democratica, di cui le proteste universitarie sono la manifestazione più evidente.
L’assenza di obiettivi chiari e condivisi, e il moltiplicarsi delle incomprensioni reciproche e delle divisioni all’interno dei rispettivi governi, rischia di trasformare il progetto israelo-americano di un protettorato neocoloniale a Gaza in un catastrofico fallimento, non disgiunto dal perdurante pericolo di una destabilizzazione regionale.





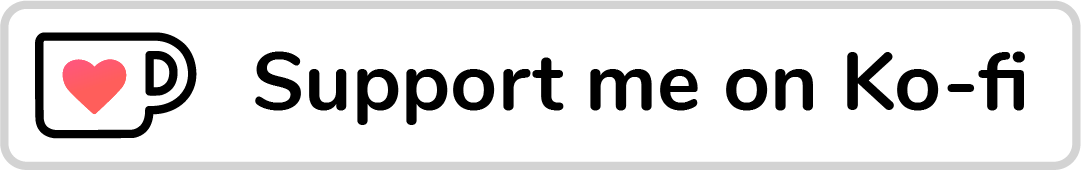
Ricordo di aver letto da qualche parte che il molo temporaneo che gli USA hanno costruito a Gaza potrebbe essere in futuro il punto di partenza di un nuovo terminale LNG per poter sfruttare i giacimenti offshore in quelle che dovrebbero essere (in teoria!) le acque territoriali di Gaza o magari parte del cosiddetto IMEC.