Da Gaza alla Siria: la guerra perenne di Israele
La prospettiva di una guerra continua su più fronti è destinata a logorare lo Stato ebraico, già indebolito da una grave crisi interna, con conseguenze difficilmente prevedibili per la sua stabilità.

Israele ha un nuovo comandante dell’esercito, il generale Eyal Zamir. Rivolgendosi a lui alla cerimonia di assunzione dei poteri, il premier Benjamin Netanyahu ha affermato che lo Stato ebraico “è determinato” ad ottenere la vittoria nella sua “guerra su più fronti” iniziata il 7 ottobre 2023.
Zamir, il quale ha dichiarato che il 2025 sarà “un anno di combattimenti”, starebbe pianificando un’operazione di terra su vasta scala per “accrescere la pressione” nei confronti di Hamas.
“Sebbene la sanguinaria organizzazione terroristica di Hamas abbia sofferto un duro colpo, non è stata ancora sconfitta. La missione non è ancora completa”, ha detto il generale.
Egli assumerà anche il comando dell’offensiva in corso nella Cisgiordania, dove l’esercito israeliano ha attaccato città e campi profughi, e per la prima volta da vent’anni a questa parte ha schierato anche carri armati.
Sebbene si sia ritirato da gran parte del Libano meridionale, Israele ha mantenuto il controllo di cinque avamposti militari in territorio libanese e continua a compiere incursioni aeree nel paese vicino.
Tel Aviv sta estendendo la propria campagna militare anche in Siria, dove ha costruito altri avamposti nella porzione delle alture del Golan occupata dopo la caduta del presidente siriano Bashar al-Assad, mentre la sua aviazione colpisce tuttora obiettivi in varie zone del paese, inclusa l’area del porto di Tartus.
Nel frattempo, F-15 ed F-35 israeliani hanno condotto esercitazioni congiunte insieme ad un bombardiere americano B-52 ed a caccia britannici – un probabile messaggio rivolto all’Iran.
Un negoziato fra Washington e Teheran rimane uno sbocco non facilmente praticabile.
Malgrado la presunta lettera inviata dal presidente americano Donald Trump all’Ayatollah Ali Khamenei, il governo iraniano ha dichiarato di non essere disposto a trattare sotto il giogo di minacce e sanzioni imposto dalla Casa Bianca (definito da quest’ultima di “massima pressione”).
Cessate il fuoco appeso a un filo
A Gaza, il cessate il fuoco in tre fasi iniziato il 19 gennaio mostra segni di cedimento, dopo che domenica 2 marzo si è conclusa la prima fase senza che i negoziati per definire i dettagli di attuazione della seconda fossero nemmeno cominciati.
Il governo Netanyahu non intende avviare la seconda fase, la quale prevede il completamento del ritiro israeliano da Gaza in cambio del rilascio dei rimanenti ostaggi da parte di Hamas. Tel Aviv rifiuta in particolare di ritirarsi dal Corridoio Philadelphi che corre lungo il confine tra la Striscia e l’Egitto.
Durante i 42 giorni della prima fase del cessate il fuoco, Israele ha più volte violato i termini dell’accordo, ritardando la consegna degli aiuti umanitari, dei macchinari per la rimozione delle macerie, e delle case mobili prefabbricate, come ha confermato lo stesso New York Times.
Le forze armate israeliane hanno più volte aperto il fuoco nella Striscia uccidendo oltre cento palestinesi dall’inizio della tregua.
Infine il governo Netanyahu ha nuovamente bloccato l’ingresso degli aiuti a Gaza per costringere Hamas ad accettare un prolungamento della prima fase, liberando altri ostaggi senza contropartita.
In concreto, Tel Aviv ha proposto di estendere la prima fase per tutto il mese di Ramadan e fino alla fine della Pasqua (19 aprile). Dei rimanenti 59 ostaggi (35 deceduti e 24 ritenuti ancora in vita), la metà verrebbe liberata il primo giorno dell’estensione della prima fase, mentre gli altri verrebbero rilasciati alla fine se nel frattempo sarà raggiunto un accordo su un cessate il fuoco permanente.
Ciò significa che, se al termine del periodo pattuito dovesse riesplodere il conflitto, solo 12 ostaggi ancora in vita rimarrebbero nelle mani di Hamas. Il gruppo palestinese ha respinto la proposta israeliana, denunciando il blocco degli aiuti come una violazione dell'accordo.
Dal canto suo, la Casa Bianca ha dichiarato di appoggiare la nuova proposta israeliana pur senza corroborare l’affermazione del governo Netanyahu secondo la quale tale proposta sarebbe stata in realtà formulata dall’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff.
Washington ha di fatto dato carta bianca a Israele sulla gestione del cessate il fuoco, dopo averne inizialmente negoziato i termini. Trump ha dichiarato di essere pronto ad accettare qualsiasi decisione presa dal governo Netanyahu, e dunque sia una prosecuzione della tregua che una ripresa delle operazioni militari.
La Casa Bianca ha però preso l’iniziativa senza precedenti di negoziare direttamente con Hamas per ottenere il rilascio degli ostaggi americani, suscitando le ire di Tel Aviv.
Politica del ricatto
I negoziati per un prolungamento del cessate il fuoco, sotto qualche forma, proseguono in un regime di minacce e intimidazioni. L’ultima proposta americana a Hamas sarebbe di liberare una decina di ostaggi in cambio di altri 60 giorni di tregua.
Nei giorni scorsi è trapelata la notizia secondo cui Israele stava preparando un “piano infernale” per obbligare Hamas a rilasciare i rimanenti ostaggi senza che le truppe israeliane completassero il ritiro da Gaza.
Il piano avrebbe previsto, oltre al blocco degli aiuti già in atto, il taglio della fornitura di acqua ed elettricità all’enclave palestinese.
La minaccia si è materializzata ieri, allorché Israele ha tagliato l’elettricità, la quale tra l’altro alimenta gli impianti di desalinizzazione che producono acqua potabile nella Striscia.
Trump ha sua volta lanciato dure minacce contro Hamas: “Rilasciate tutti gli ostaggi ora, non in un secondo momento […] o per voi è finita”. Il presidente ha affermato: “Sto inviando a Israele tutto ciò di cui ha bisogno per finire il lavoro, non un singolo membro di Hamas sarà al sicuro se non fate ciò che vi dico”.
Appena insediatasi, la nuova amministrazione USA ha dato impulso a una nuova campagna di riarmo di Israele, inviando migliaia di bombe da 2.000 libbre ed approvando aiuti militari del valore di 4 miliardi di dollari.
Lo stesso segretario di Stato Marco Rubio ha recentemente lasciato intendere che l’obiettivo finale rimane l’eliminazione del gruppo palestinese che governa Gaza: “alla fine qualcuno dovrà intervenire e sbarazzarsi di Hamas”.
La situazione umanitaria nella Striscia rimane drammatica. Secondo dati ONU, il 69% delle infrastrutture complessive dell’enclave palestinese è stato distrutto o danneggiato.
In particolare, l’88% del settore commerciale e industriale, l’81% della rete stradale, l’82% dei terreni coltivati e il 78% delle serre.
Il 95% del bestiame è morto. Il 95% degli ospedali ha subito danni significativi. Complessivamente, l’economia della Striscia si è contratta dell’83%, e l’intera popolazione è ridotta a dipendere dagli aiuti alimentari per sopravvivere.
Secondo la rivista Lancet, nei primi 12 mesi del conflitto l’aspettativa di vita a Gaza è crollata da 75,5 anni ad appena 40,5, la più bassa al mondo (18 anni meno che in Somalia, 14 meno che in Nigeria).
Il piano egiziano
Nel frattempo, Netanyahu ha più volte manifestato il proprio appoggio al piano di pulizia etnica della Striscia proposto da Trump a inizio febbraio, il quale prevede la deportazione degli abitanti dell’enclave in Egitto, Giordania ed altri paesi.
La scorsa settimana, ad un incontro al Cairo, i paesi arabi hanno approvato una controproposta formulata dall’Egitto, la quale prevede un piano di ricostruzione da 53 miliardi di dollari che permetterebbe agli abitanti della Striscia di non abbandonare la loro terra.
Il piano è suddiviso in tre fasi per un periodo complessivo di cinque anni. La prima, della durata di sei mesi, prevede la consegna di rifugi temporanei alla popolazione e l’inizio della rimozione dei 50 milioni di tonnellate di macerie in diversi punti dell’enclave.
La seconda fase, della durata di due anni, include la costruzione di circa 200.000 appartamenti. Una quantità equivalente dovrebbe essere costruita in altri due anni e mezzo. Il piano prevede anche la costruzione di un porto e di un aeroporto internazionale.
Durante la prima fase, Gaza dovrebbe essere governata da una commissione di tecnici palestinesi indipendenti la quale dovrebbe gestire gli affari amministrativi e di sicurezza, e la distribuzione degli aiuti.
Successivamente, al termine di una serie di riforme interne, l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) che attualmente amministra la Cisgiordania occupata dovrebbe estendere il proprio controllo alla Striscia.
Egitto e Giordania si assumerebbero il compito di addestrare una forza di polizia palestinese che sarebbe controllata dall’ANP.
Il piano prevede che, durante la prima fase, inizino negoziati diretti fra Israele ed i rappresentanti palestinesi che portino alla soluzione delle questioni dello “status finale” degli Accordi di Oslo, inclusa la definizione dei confini di un futuro Stato palestinese e lo status della città contesa di Gerusalemme.
La proposta egiziana affronta anche la questione delle armi di Hamas, affermando che “un chiaro orizzonte e un credibile processo politico” per l’autodeterminazione palestinese è un prerequisito per il disarmo.
Il piano è stato accolto favorevolmente dall’ONU e dalla stessa organizzazione di Hamas, che si è detta disposta a cedere il potere pur senza deporre le armi. Esso è stato però rifiutato da Israele e sostanzialmente scartato anche dall’amministrazione Trump.
Il governo Netanyahu ritiene il disarmo di Hamas propedeutico a qualsiasi altra considerazione, e vorrebbe che i paesi arabi si facessero carico della questione, prefigurando così un possibile scontro fra essi e Hamas (una sorta di guerra civile fra arabi).
Del resto, Israele rifiuta anche la prospettiva che sia l’ANP a governare Gaza. E va ricordato che, ben prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu si è ripetutamente detto contrario alla creazione di uno Stato palestinese.
Nel frattempo, anche negli USA continuano a circolare piani che prevedono l’emigrazione “volontaria” di almeno il 40% della popolazione di Gaza.
“Muro di Ferro” in Cisgiordania
La tragedia palestinese non si limita però alla Striscia. All’interno del governo Netanyahu cresce la tentazione di cercare di liquidare una volta per tutte la questione palestinese.
Ad appena 48 ore dall’entrata in vigore del cessate il fuoco del 19 gennaio a Gaza, Tel Aviv ha lanciato un’operazione militare senza precedenti in Cisgiordania.
Denominata “Muro di Ferro”, l’operazione coinvolge più di dodici battaglioni dell’esercito, la polizia di confine, e lo Shin Bet (i servizi segreti interni). Essa ha incluso anche bombardamenti aerei, e l’utilizzo di droni, quadricotteri, carri armati e altri mezzi corazzati.
L’azione militare è rivolta ufficialmente contro i gruppi armati emersi nei campi profughi di Jenin, Tulkarm , Nur Shams e Tubas a seguito di precedenti pesanti incursioni compiute da Israele subito dopo il 7 ottobre 2023.
La campagna si è però rivelata una vera e propria operazione di pulizia etnica che ha espulso dai campi 40.000 persone, alle quali non sarà permesso di fare ritorno secondo quanto dichiarato dagli stessi responsabili israeliani.
La distruzione provocata dalle forze armate di Tel Aviv nei campi e nelle aree urbane adiacenti è stata così massiccia che i residenti hanno descritto i loro quartieri come ormai ridotti a delle “piccole Gaza”.
I bulldozer israeliani hanno distrutto abitazioni e strade, la rete elettrica e quella idrica, così come le torri della rete wireless. Il ministro delle finanze Bezalel Smotrich ha dichiarato a metà febbraio che “l’obiettivo del 2025 è demolire più di quanto i palestinesi costruiscano in Cisgiordania”.
Nel frattempo il governo israeliano sta costruendo circa 1.000 nuove unità abitative nell’insediamento di Efrat a ridosso di Gerusalemme.
Nelle circa 100 colonie israeliane (illegali in base al diritto internazionale) che sono ormai presenti sul territorio della Cisgiordania, abitano 500.000 coloni. Smotrich da tempo ambisce ad annettere la Cisgiordania a Israele, come ha chiarito in un articolato testo programmatico intitolato “Il Piano Decisivo” e pubblicato nel 2017.
Avamposti militari e attacchi in Libano
Le forze armate israeliane rimangono impegnate anche in territorio libanese, malgrado il ritiro parziale avvenuto il 19 febbraio, seconda scadenza fissata dall’accordo di cessate il fuoco con Beirut entrato in vigore lo scorso novembre.
L’accordo prevedeva il totale ritiro israeliano dal sud del Libano in cambio del ridispiegamento di Hezbollah a nord del fiume Litani, situato a circa 30 km dal confine. A sud del fiume, in base a quanto stipulato, si sarebbe schierato l’esercito libanese insieme ai soldati dell’UNIFIL, la forza di pace delle Nazioni Unite da tempo presente nel paese.
Tuttavia, accusando il Libano di non aver rispettato pienamente l’accordo, Tel Aviv ha dapprima prolungato la propria occupazione, e dopo il ritiro del 19 febbraio ha mantenuto il controllo di cinque avamposti militari situati su altrettante alture in territorio libanese.
La decisione israeliana ha suscitato le dure proteste del nuovo governo di Beirut guidato dal presidente Joseph Aoun, il quale si è appellato agli Stati Uniti e agli altri mediatori internazionali coinvolti nell’accordo affinché spingano Israele a completare il proprio ritiro.
Il ministro degli esteri libanese Joe Rajji ha anche proposto che siano gli uomini dell’UNIFIL a prendere il controllo dei cinque avamposti, ma senza esito.
Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha recentemente dichiarato che il suo paese manterrà il controllo “a tempo indeterminato” di quella che ha definito una “zona cuscinetto”, affermando di aver ricevuto il benestare degli Stati Uniti.
I cinque avamposti sono situati su alture strategiche in prossimità del confine e assicurano alle forze israeliane ampia visibilità su gran parte del sud del Libano.
L’aviazione militare di Tel Aviv ha continuato a colpire obiettivi in territorio libanese anche dopo il ritiro del 19 febbraio. Lo scorso 7 marzo, esse hanno compiuto più di trenta attacchi aerei su città e villaggi del sud del paese confinante contro presunti obiettivi di Hezbollah.
Destabilizzare la Siria
All’indomani della caduta del presidente siriano Bashar al-Assad, le truppe israeliane hanno creato un’ulteriore zona cuscinetto in Siria, in corrispondenza del Golan occupato, prendendo il controllo della vetta del Monte Hermon (il più alto del paese, con i suoi quasi 3.000 metri sul livello del mare), e arrivando a poche decine di chilometri da Damasco.
Netanyahu ha chiarito già a dicembre che la nuova occupazione non è intesa come una misura temporanea in attesa che la Siria si stabilizzi, ma sarà “a tempo indeterminato”.
Anche in questa nuova porzione di territorio occupato, le forze israeliane hanno costruito almeno sette avamposti e fortificazioni militari, rivelati da immagini satellitari.
Esprimendo una strategia ancor più ambiziosa, lo scorso 23 febbraio il premier israeliano ha chiesto la totale smilitarizzazione della Siria a sud di Damasco.
“Non permetteremo alle forze di Hay’at Tahrir al-Sham [l’organizzazione armata che ha rovesciato Assad] o all’esercito della nuova Siria di entrare nel territorio a sud di Damasco”, ha dichiarato Netanyahu.
Nello stesso discorso, egli si è autoproclamato difensore della minoranza drusa (presente anche in Libano, Israele e Giordania), affermando che “non tollereremo alcuna minaccia alla comunità drusa nel sud della Siria”.
Le affermazioni del premier israeliano hanno suscitato vive proteste sul territorio siriano, sia all’interno della comunità drusa che nel resto della popolazione.
La scelta di Netanyahu di proporsi come difensore dei drusi rientra in una tradizionale strategia di Israele che, considerandosi minoranza nella regione, punta ad un’alleanza con altre minoranze come drusi, curdi e cristiani, al fine di indebolire la maggioranza araba sunnita.
In Siria, il governo Netanyahu punta a creare una “mezzaluna” curdo-drusa nel sud e nell’est del paese, che simpatizzi per Israele, limiti l’influenza turca, e crei una sorta di corridoio in grado di collegare lo Stato ebraico con il Kurdistan iracheno, altra regione che ha stretti legami con Tel Aviv.
Tale corridoio sarebbe reso possibile anche dalla base americana di al-Tanf situata lungo il confine sudorientale siriano in prossimità di Giordania e Iraq.
Lo scorso gennaio in Israele, la Commissione della Difesa nota come “Commissione Nagel” (dal nome dell’ex capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale da cui è presieduta) ha messo in guardia nel suo ultimo rapporto che la crescente influenza della Turchia in Siria rappresenterebbe una grave minaccia per Tel Aviv.
Da qui la decisione israeliana di pretendere la demilitarizzazione della Siria meridionale e di cercare un’alleanza con i curdi, e possibilmente con i drusi, per mantenere il paese vicino debole e diviso.
Alla luce dei violenti scontri registratisi in questi giorni tra le forze governative siriane e la minoranza alawita da cui proveniva il regime di Assad, i quali hanno portato al massacro di centinaia di civili da parte delle prime, l’obiettivo israeliano appare a portata di mano.
Resta il fatto che la continua moltiplicazione dei fronti sui quali Israele è militarmente impegnato, oltre a contribuire ad una pericolosa destabilizzazione regionale, ha posto Tel Aviv in un tunnel dal quale il governo Netanyahu non sembra in grado di uscire.
La prospettiva di una guerra perenne su più fronti è destinata a logorare lo Stato ebraico, già indebolito da una grave crisi interna, con conseguenze difficilmente prevedibili per la sua stabilità.




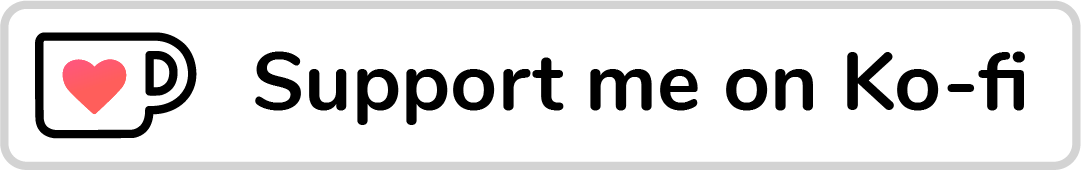
Vorrei solo che tu avessi ragione, è angosciante questo continuo incremento di disumanita'
Spero vivamente che le tue previsioni siano esatte e che Israele imploda, sarebbe una liberazione per i palestinesi, il Medio Oriente e il mondo intero. Purtroppo non riesco a illudermi che sarà così: si starà logorando, ma ha il supporto inesauribile degli USA che lo rende inattaccabile e non per suo merito. Fanno i bulli sterminando i popoli, ma da soli non durerebbero un mese. Grazie dei preziosi ed esaustivi aggiornamenti, Roberto.