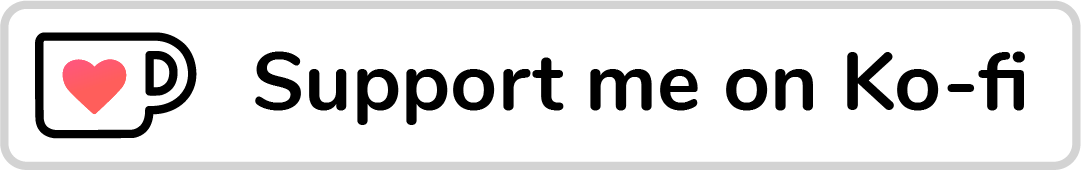Trump torna sul trono di un’America in crisi
Come già durante il primo mandato ottenuto nel 2016, Trump rappresenta un sintomo – non la causa – della crisi degli Stati Uniti, e di certo non ha in mano la ricetta per arrestarne il declino.

Non è stato un testa a testa, come annunciavano tutti i sondaggi. Donald Trump ha vinto con grande margine, aggiudicandosi almeno 295 collegi (270 sono necessari per ottenere la presidenza) e lasciando Kamala Harris a 226 (dati quasi definitivi).
Il magnate repubblicano ha prevalso nei principali swing states (Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Georgia). Cosa non scontata, si è aggiudicato anche il voto popolare, con oltre 73 milioni di preferenze (la Harris è rimasta a 69).
I repubblicani hanno ottenuto la maggioranza al Senato (almeno 53 seggi) e sembrano avviati a mantenerla anche alla Camera. Trump ha attirato il voto della classe lavoratrice, dei giovani, dei neri, degli ispanici. Una vittoria che appare schiacciante su tutti i fronti.
Le ragioni del tracollo democratico
Come hanno fatto i democratici a perdere di fronte a un avversario che essi vedevano come un ex presidente due volte posto sotto impeachment, un criminale, un fascista, un buffone continuamente dileggiato?
Ecco alcune risposte a questo interrogativo, che perfino il New York Times ha saputo chiaramente elencare a posteriori: la designazione della Harris, un candidato debole, durante un frettoloso e antidemocratico processo di successione al presidente uscente Joe Biden; la sua incapacità di differenziarsi da quest’ultimo; la sua sciocca insistenza nel definire Trump “un fascista”, la quale implicava che anche i suoi sostenitori lo fossero; la sua eccessiva dipendenza dalle celebrità affiancata ad un’evidente inabilità a formulare una motivazione convincente per la sua candidatura.
Nemmeno la guerra di sterminio condotta da Israele a Gaza, con la piena complicità e collaborazione dell’amministrazione Biden, ha favorito i democratici.
Ma soprattutto non ha giovato loro l’ostinata quanto infondata convinzione che le cose andassero bene nell’America di Biden, e che chiunque la pensasse diversamente fosse un propagandista di destra, o una specie di traditore.
E certamente a prima vista le cose non vanno così male negli USA. Wall Street vola (ed ha accolto favorevolmente anche la vittoria di Trump), il dollaro è forte, l’economia ha un tasso di crescita intorno al 2,5% del PIL, la disoccupazione non supera il 4,1%.
Ma la realtà è un’altra: con la crisi seguita al Covid-19 gli americani hanno assistito a un terribile crollo del loro tenore di vita, dovuto a un aumento dei prezzi al consumo di beni e servizi violento tra il 2021 e il 2022, e robusto ancora oggi.
Se le cose vanno a gonfie vele per miliardari e grandi investitori, per l’americano medio è tutta un’altra storia. I prezzi di mutui e assicurazioni sono schizzati alle stelle.
La disuguaglianza negli Stati Uniti è fra le più elevate al mondo, e continua ad aumentare. L’1% più ricco della popolazione possiede più del 30% della ricchezza del paese. Il 50% più povero ne possiede appena l’1%.
Mentre volano i prezzi delle assicurazioni sanitarie, aumentano le scorte di prodotti invenduti, e la spesa pubblica va ad alimentare la produzione di armi. Il settore manifatturiero ha continuato a contrarsi per 7 mesi consecutivi.
Il fallimento di Biden
Nel 2020, il Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan teorizzava che la forza della politica estera e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti risiede principalmente in una fiorente classe media “la cui prosperità è messa a repentaglio da quelle stesse minacce transnazionali che l’amministrazione Trump ha cercato di minimizzare o ignorare”.
Così la presidenza Biden aveva lanciato la sua cosiddetta “politica estera per la classe media”. Si trattava di un buon modo per prendersela con l’amministrazione precedente, e per sollevare le élite americane dalla responsabilità di aver distrutto la classe media, accollandola invece a “subdoli attori stranieri”.
Era anche un tentativo di ricostruire un minimo di fiducia interna mentre l’élite del paese si preparava ad una lunga battaglia contro Cina, Russia e chiunque altro si opponesse alla declinante egemonia USA.
Lo sforzo di riportare in patria produzione e posti di lavoro non ha però dato i frutti sperati. L’idea di creare un’industria autoctona dei semiconduttori si è scontrata con la carenza di lavoratori qualificati.
L’unico “successo” dell’amministrazione Biden è consistito nel rilocalizzare sul territorio americano alcune industrie europee, e nel garantire profitti al complesso militare-industriale ed al settore energetico, al prezzo di indebolire i propri alleati nel vecchio continente. Tuttavia con poche ricadute positive per la classe media americana.
Come ha scritto l’economista Michael Hudson, è lo stesso modello neoliberista statunitense ad affossare la competitività USA a livello internazionale sotto il profilo produttivo.
La manodopera americana deve fronteggiare costi talmente esorbitanti – per le abitazioni, l’istruzione, l’assicurazione sanitaria, e tutti i servizi privatizzati – che non potrà mai emergere a livello internazionale per competitività dei salari.
Nel complesso, dunque, lo slogan dell’amministrazione si è rivelato per quello che era: una trovata propagandistica con poche ricadute concrete.
Polarizzazione preelettorale
Ma l’economia è solo uno degli elementi di una crisi molteplice e profondamente radicata.
I mesi preelettorali sono stati caratterizzati da un susseguirsi di emergenze, dalle tensioni internazionali con la Russia agli allarmi sanitari veri o presunti, alla crisi climatica, alla forzosa successione da Joe Biden a Kamala Harris nella casa democratica, ai falliti attentati contro il candidato repubblicano Donald Trump, mentre il debito pubblico USA veleggia oltre la cifra record dei 35.000 miliardi di dollari.
La grave e annosa crisi sociale si traduce in un allarmante numero di suicidi e di decessi per la dipendenza da alcol e oppioidi.
Alla vigilia del voto, tre quarti degli elettori ritenevano che il paese stesse andando nella direzione sbagliata. Secondo alcuni exit poll, il 61% di questi ha votato per Trump. Degli elettori che si sono definiti “arrabbiati”, il 71% ha dato la preferenza ai repubblicani. Il 79% di coloro che hanno affermato che l’economia è la loro maggiore preoccupazione ha appoggiato Trump.
Ma non si è trattato solo di un voto di protesta. Secondo un sondaggio condotto alla vigilia delle presidenziali, il 76% degli americani ritiene che la democrazia nel paese sia minacciata. Il 45% crede che non rappresenti adeguatamente le persone.
La campagna elettorale è stata condotta all’insegna di un’aspra polarizzazione, caratterizzata da teorie della cospirazione, insinuazioni su potenziali brogli, accuse e insulti reciproci.
Ciascuno schieramento ha lasciato più o meno esplicitamente intendere che la vittoria del candidato avversario avrebbe significato la fine della democrazia (sebbene i democratici abbiano ora riconosciuto la legittima vittoria di Trump).
Contraddistintosi per un linguaggio divisivo e offensivo, Trump è stato a sua volta accusato di fascismo e più volte paragonato a Hitler.
Ad arroventare ulteriormente il clima preelettorale ci si sono messe le ennesime insinuazioni più o meno infondate, avanzate dalla comunità dell’intelligence, sulle presunte ingerenze straniere nella campagna elettorale da parte di paesi come Russia, Cina e Iran.
Plutocrazia
Ma le vere ingerenze nel processo democratico americano provengono dall’interno. Le presidenziali del 2024 sono state le seconde più costose nella storia degli Stati Uniti, con quasi 16 miliardi di dollari spesi.
Quest’incredibile ammontare di denaro è stato superato solo da quello delle presidenziali del 2020, che raggiunse la cifra esorbitante di 18,3 miliardi.
Solitamente, i candidati che ricevono più soldi sono quelli che vincono. A determinare i risultati delle elezioni sono dunque i ricchi donatori che foraggiano i candidati di entrambi gli schieramenti.
Questo fenomeno è direttamente legato ad uno ancora più impressionante, quello della smisurata concentrazione di capitali nelle mani di un esiguo numero di individui e soggetti economici.
Tra questi figurano società di investimento come BlackRock, Vanguard, State Street, Morgan Stanley, che a loro volta investono nelle grandi corporation americane, dal settore petrolifero a quello dell’industria bellica, da Silicon Valley al settore farmaceutico ed a quello delle biotecnologie.
Alla luce di questa enorme concentrazione di capitali, e dell’influenza che essa esercita sul processo politico e su quello elettorale, ogni parvenza di democrazia scompare.
Come ha affermato Larry Fink (il miliardario amministratore delegato di BlackRock) alla vigilia delle presidenziali, “non importa veramente” chi sarebbe stato il vincitore fra Trump e la Harris.
“Sono stanco di sentirmi dire che queste sono le più importanti elezioni della nostra vita. La realtà è che con il passare del tempo non importa veramente”, ha detto Fink, aggiungendo che “noi lavoriamo con entrambe le amministrazioni e abbiamo conversazioni con entrambi i candidati”.
Un altro esempio a tale proposito è fornito dall’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), la potentissima lobby israeliana che finanzia candidati appartenenti a entrambi i partiti.
Verso un “cesarismo” trumpiano?
Nella campagna presidenziale, sia la Harris che Trump hanno potuto vantare un considerevole stuolo di miliardari, CEO delle grandi corporation, e venture capitalist della Silicon Valley che appoggiavano e finanziavano il loro partito.
A sostegno della prima si sono schierati Bill Gates, la famiglia Soros, l’ex CEO di Google Eric Schmidt, Alex Karp (cofondatore di Palantir, società che produce sistemi di intelligenza artificiale ad uso bellico, impegnata in Ucraina ed al fianco di Israele), e molti altri.
In appoggio al secondo possiamo citare nomi come Elon Musk, Miriam Adelson (vedova di Sheldon, entrambi grandi sostenitori di Israele), l’amministratore delegato di Blackstone Stephen Schwarzman, Peter Thiel (socio di Karp alla guida di Palantir), ecc.
Con la Harris si sono schierati anche una serie di ex esponenti del Pentagono e dell’intelligence, e figure neocon come Liz Cheney. Come al solito, tuttavia, i neocon hanno cercato di farsi strada in entrambi gli schieramenti.
Da tenere in considerazione anche le tesi che circolano fra alcuni “ideologhi” del fronte trumpiano, vicini a figure come Musk e Thiel, secondo le quali gli Stati Uniti stanno attraversando un periodo paragonabile a quello della Roma tardo-repubblicana, in attesa che il proprio Cesare prenda il potere.
Del resto, nell’ultimo quarto di secolo, la presidenza americana ha accumulato una quantità crescente di poteri a scapito del Congresso, soprattutto per quanto riguarda la politica estera e le operazioni belliche.
La possibilità che durante il secondo mandato Trump, l’unilateralismo presidenziale compia un ulteriore salto di qualità, sfociando realmente in una sorta di “cesarismo”, non è da scartare.
Un turbolento declino
Ma, a differenza della Roma tardo-repubblicana, gli USA sono un impero in ritirata, in una fase avanzata di crisi in patria e all’estero, ossessionato dall’idea di preservare la propria residua egemonia.
Joseph Nye, l’inventore del concetto di “soft power” negli anni ’90 del secolo scorso, si definisce “cautamente ottimista” sulla possibilità che gli Stati Uniti conservino il primato, ma teme che essi abbiano finito per smarrire il proprio soft power, il potere di attrazione che li aveva contraddistinti fino a pochi anni fa.
Frederick Kempe, presidente dell’Atlantic Council (uno dei think tank più influenti, ma anche più aggressivi, a Washington) ha scritto alla vigilia delle presidenziali che, a prescindere da chi avrebbe vinto, il successore di Biden sarebbe stato un “presidente di guerra”.
Il nuovo inquilino della Casa Bianca avrebbe dovuto fronteggiare i rischi rappresentati dalla crescente collaborazione di paesi come Cina, Russia, Iran e Corea del Nord. Kempe ha paragonato le attuali presidenziali a quelle del 1940, che confermarono alla presidenza Franklin Delano Roosevelt alla vigilia del secondo conflitto mondiale.
Trump, dal canto suo, ha detto di voler porre fine alle imprese militari americane all’estero, e di volersi disimpegnare dall’Ucraina, ma nel precedente mandato ha finito per circondarsi di estremisti e guerrafondai (McMaster, Pompeo, Bolton, solo per citarne alcuni), e probabilmente intensificherà la guerra commerciale con la Cina e forse anche con l’Europa.
Il suo piano economico fondato su taglio indiscriminato delle tasse (in particolare per i ricchi), deregulation, e protezionismo, difficilmente risolleverà la classe media del paese.
Egli dovrà barcamenarsi fra le varie correnti del proprio partito e dell’establishment USA (ultimamente definite, in maniera alquanto colorita, come primacists, prioritizers, e restrainers, a seconda dell’impegno che esse intendono spendere nella competizione tra grandi potenze).
Trump potrebbe farsi risucchiare in un ennesimo conflitto mediorientale, questa volta su larga scala, trascinato dalla volontà dell’alleato israeliano di regolare i conti con i propri avversari regionali, da Hamas all’Iran.
Nel complesso, è probabile che il nuovo mandato del magnate repubblicano sarà contrassegnato, oltre che dalle tensioni e dai conflitti internazionali eredità della presidenza Biden, anche dall’acuirsi delle contrapposizioni interne, in quello che si profila come un nuovo stadio della crisi di leadership e di democrazia nella quale gli USA continueranno a sprofondare.
Come già durante il primo mandato del 2016, Trump rappresenta un sintomo – non la causa – della crisi degli Stati Uniti, e di certo non ha in mano la ricetta per arrestarne il declino.