Siria, Libano, Iran, Iraq: escalation di attentati e attacchi in Medio Oriente
Una serie impressionante di attacchi, attribuiti a Israele, all’ISIS e agli USA, e rivolti invariabilmente contro l’asse iraniano in Medio Oriente, accresce i rischi di destabilizzazione regionale.
Negli ultimi dieci giorni, a cavallo fra il vecchio e il nuovo anno, una progressione sconcertante di attentati ha colpito obiettivi legati all’asse iraniano in Medio Oriente. La serie ha avuto inizio con l’uccisione del generale iraniano Radhi Mousavi lo scorso 25 dicembre a Damasco, in Siria. Il 2 gennaio, un attacco missilistico (probabilmente compiuto da un drone) ha ucciso Saleh al-Arouri, uno dei principali esponenti del movimento islamico palestinese Hamas, insieme ad altri uomini del gruppo, nel sobborgo meridionale di Beirut, considerato la roccaforte del gruppo sciita libanese Hezbollah. Il giorno dopo, una doppia esplosione nei pressi della tomba del generale Qassem Soleimani, a Kerman, in Iran, ha mietuto quasi cento vittime fra i presenti giunti a commemorare il comandante assassinato quattro anni fa dagli USA in Iraq. Infine, proprio in Iraq gli Stati Uniti hanno ucciso, ancora una volta tramite un drone, il leader di una milizia filo-iraniana il 4 gennaio.
Questa sanguinosa serie di episodi infiamma ulteriormente un panorama mediorientale già profondamente scosso dal terribile conflitto in corso a Gaza e dalle sue ramificazioni regionali, fra le quali spiccano lo scontro militare fra Israele e Hezbollah (fino a questo momento limitato a reciproci bombardamenti lungo il confine libanese), e le tensioni nel Mar Rosso causate dagli attacchi alle navi mercantili dirette verso Israele da parte della formazione sciita yemenita di Ansar Allah (meglio nota come movimento degli Houthi, dal nome del suo fondatore).
Attacco al cuore del potere iraniano a Damasco
Sebbene passata quasi sotto silenzio in Occidente, l’uccisione di Radhi Mousavi, comandante della Guardia rivoluzionaria iraniana in Siria, aveva già rappresentato un evento di enorme portata per la rilevanza del personaggio, paragonato da alcuni allo stesso Qassem Soleimani, figura carismatica e fra le più venerate in Iran.
Mousavi era un alto ufficiale con decenni di esperienza in Siria e Libano, ed era responsabile dei rapporti tra la forza “Quds”, ramo della Guardia rivoluzionaria operante all’estero di cui Soleimani era stato comandante, e il governo siriano. Sotto la sua responsabilità ricadeva la gestione delle forze iraniane in Siria, così come l’invio di armi al regime di Damasco e a Hezbollah in Libano.
Per anni Mousavi aveva lavorato a stretto contatto con Soleimani, essendo di fatto il suo braccio destro nella regione del Levante arabo. Dopo l’assassinio di quest’ultimo ad opera di un drone americano in Iraq nel gennaio 2020, Mousavi era stato nominato alla guida della sezione della Guardia rivoluzionaria iraniana in Siria.
Significativo anche il luogo in cui egli è stato ucciso. Si tratta del sobborgo meridionale di Damasco noto col nome di Sayyidah Zainab, che ospita il più importante santuario sciita in Siria, dove ogni anno giungono milioni di pellegrini da numerosi paesi. Il sobborgo è divenuto anche un centro dell’influenza iraniana in Siria, e un quartier generale della forza Quds dopo lo scoppio della guerra civile siriana nel 2011. Gli attentatori hanno dunque colpito Mousavi nel cuore del potere iraniano a Damasco.
L’attentato – attribuito da molti a Israele, sebbene Tel Aviv raramente si assuma ufficialmente la responsabilità di simili operazioni – ha avuto luogo nel contesto di uno scontro tuttora limitato, ma di crescente intensità, fra il cosiddetto “asse della resistenza” (come si autodefinisce lo schieramento iraniano nella regione, composto da Hamas, Hezbollah, Siria, milizie irachene, Houthi yemeniti e Iran) da un lato, e Israele e gli USA dall’altro.
Tale scontro, iniziato all’indomani dell’attacco del 7 ottobre in Israele per mano di Hamas e di altre fazioni palestinesi alleate, ha coinvolto non solo Hezbollah e l’esercito israeliano al confine fra Libano e Israele, ma anche la basi americane in Siria e Iraq, che sono state bersagliate dalle milizie filo-iraniane locali con razzi e droni, provocando diversi feriti tra i soldati americani. Israele è inoltre ripetutamente intervenuto in Siria, bombardando obiettivi iraniani e gli aeroporti di Damasco e Aleppo.
In tale confronto, come abbiamo visto, si sono inseriti anche gli Houthi yemeniti, lanciando missili e droni contro il porto israeliano di Eilat (solitamente abbattuti dalle difese israeliane), e prendendo di mira le navi mercantili nel Mar Rosso.
A Beirut, attacco al nesso fra Hamas e Iran
Nei giorni successivi all’assassinio di Mousavi non vi era stata alcuna rappresaglia significativa da parte iraniana.
Nel tardo pomeriggio del 2 gennaio, tuttavia, un drone israeliano ha colpito un ufficio di Hamas nella Dahiyeh, la periferia meridionale di Beirut nota per essere una roccaforte di Hezbollah, uccidendo Saleh al-Arouri, vicecapo dell’ufficio politico di Hamas, e altri cinque membri dell’organizzazione.
Arouri gestiva le operazioni di Hamas in Cisgiordania, ma era anche responsabile dei rapporti fra il movimento palestinese, il partito sciita libanese Hezbollah e l’Iran. Essendo tra i fondatori delle Brigate Izz al-Din a-Qassam, l’ala militare di Hamas, egli aveva un legame diretto (anche se non privo di attriti) con Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza, e con Mohammed Deif, comandante supremo dell’ala militare del gruppo. Ma Arouri aveva anche ottimi rapporti con i leader di Hamas in esilio in Qatar, Ismail Haniyeh e Khaled Meshaal.
Arouri era stato uno dei protagonisti del riavvicinamento di Hamas con l’Iran dopo la frattura consumatasi fra il gruppo e Teheran a causa della guerra in Siria (dove il movimento palestinese si era in gran parte schierato con i ribelli).
Dopo aver trascorso quindici anni nelle carceri israeliane, al momento del rilascio Arouri era stato espulso in Turchia, poi si era rifugiato in Qatar (a seguito del riavvicinamento fra Ankara e Tel Aviv), ed infine era stato accolto in Libano.
Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, il governo israeliano aveva affermato che avrebbe colpito i leader del gruppo ovunque nel mondo. La dirigenza del movimento all’estero è attualmente sparpagliata fra Qatar, Turchia e Libano. Il primo di questi paesi è tuttavia un importante partner degli USA, ne ospita la strategica base militare di al-Udeid, ed ha svolto un importante ruolo di mediazione in vari teatri di guerra nel mondo. Esso è un intermediario anche nel negoziato sulla liberazione degli ostaggi israeliani in mano a Hamas.
Il presidente turco Erdogan, dal canto suo, aveva minacciato pesanti ritorsioni nel caso in cui Israele avesse compiuto omicidi mirati sul territorio turco. Per Tel Aviv, il Libano era dunque il teatro più facile dove operare. Ma colpire obiettivi in territorio libanese avrebbe comportato un inasprimento delle tensioni con Hezbollah. La decisione di uccidere Arouri nel suo ufficio nella Dahiyeh segna dunque una seria escalation da parte israeliana.
Il dilemma di Hezbollah
Arouri non era nascosto in qualche bunker, ma si trovava in una comune zona residenziale nel sobborgo meridionale di Beirut. Ciò che aveva protetto finora i leader di Hamas nella capitale libanese era l’equilibrio di deterrenza che sussisteva fra Israele e Hezbollah dopo la guerra del 2006. Era da allora, infatti, che in base alle “regole di ingaggio” fra i due nemici, Tel Aviv non colpiva obiettivi a Beirut. L’uccisione di Arouri segna una violazione di questa regola non scritta, e dunque una sfida aperta nei confronti di Hezbollah.
Tuttavia, colpendo una personalità palestinese piuttosto che un alto rappresentante del movimento sciita libanese, gli israeliani hanno tentato di giocare sul ruolo controverso che la presenza palestinese in Libano ha sempre avuto fra i libanesi.
Difficilmente Hezbollah potrà permettersi di trascinare il paese in una guerra devastante per vendicare l’uccisione di un palestinese. Va però rilevato che, sebbene Israele abbia tentato per decenni di sfruttare le divisioni libanesi, in fin dei conti ha sempre fallito, determinando l’ascesa di un nemico progressivamente più coeso e determinato.
La scorsa estate, il premier israeliano Netanyahu aveva apertamente minacciato di uccidere Arouri. Il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, aveva risposto che qualunque assassinio da parte israeliana in territorio libanese avrebbe provocato una dura risposta da parte del movimento, a prescindere dall’identità libanese, iraniana o palestinese dell’obiettivo colpito da Israele.
A seguito della guerra in corso a Gaza, e del rischio di allargamento del conflitto al Libano, è però probabile che i calcoli strategici di Hezbollah siano cambiati. Arouri non è più importante di Mousavi o di Soleimani, sebbene questi ultimi non siano stati uccisi in territorio libanese. Hezbollah, poi, oltre a dover tener conto del benessere della comunità sciita del paese, ha responsabilità di governo e deve perciò considerare tutte le componenti della società libanese.
E’ perciò probabile che il movimento escogiterà una rappresaglia che rimanga al di sotto della soglia in grado di scatenare un conflitto aperto fra Israele e Libano, eventualmente lasciando che sia lo stesso Hamas, che opera anche dal territorio libanese, ad assumersi l’onere di rispondere all’attacco israeliano.
Israele detta la linea, Washington subisce
Il fronte libanese rimane tuttavia incandescente. I bombardamenti al confine proseguono ininterrotti dal giorno successivo all’attacco di Hamas del 7 ottobre, e sono progressivamente cresciuti d’intensità. Sebbene entrambe le parti abbiano finora evitato di colpire in profondità il territorio nemico, tali bombardamenti hanno portato all’evacuazione di decine di migliaia di libanesi e israeliani, rispettivamente a nord e a sud del confine.
Gli USA hanno più volte manifestato la loro contrarietà a un allargamento del conflitto, e hanno mandato ripetutamente Amos Hochstein, inviato speciale del presidente Biden, in Libano per cercare di contenere i rischi di escalation, allo stesso tempo spedendo il segretario di Stato Blinken e quello alla Difesa Lloyd Austin in Israele per esortare il governo Netanyahu a non esacerbare la situazione.
La Casa Bianca si è tuttavia astenuta dal minacciare ritorsioni reali nei confronti di Israele, come ad esempio una riduzione dell’invio di armi essenziali per lo sforzo bellico israeliano a Gaza. Tel Aviv, dal canto suo, ha mostrato di non tenere in gran conto le semplici esortazioni americane.
Da diverse fonti è emerso che l’assassinio di Arouri è stato pianificato da Israele in piena autonomia, senza consultarsi preventivamente con l’alleato statunitense. Washington è stata avvertita solo ad operazione in corso.
Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller si è astenuto dal chiarire se gli USA appoggino o meno l’assassinio di Arouri. John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, ha invece commentato così:
“Non riteniamo che gli attacchi militari da soli riusciranno a sradicare un’ideologia, ed è improbabile che ci si possa sbarazzare di ogni singolo combattente di Hamas. Ciò che si può assolutamente fare è sradicare la minaccia che Hamas rappresenta per il popolo israeliano. E ciò si può fare perseguendo la leadership, […] colpendo le loro infrastrutture, […] e le loro risorse”.
Nuova fase a Gaza, secondo fronte in Libano?
Con l’uccisione di Arouri, è in effetti la prima volta che Israele riesce a sbarazzarsi di un alto dirigente di Hamas dall’inizio del conflitto. Malgrado l’enorme sforzo bellico e l’immane distruzione prodotta, a Gaza gli israeliani non sono riusciti a scovare nessuno dei leader, probabilmente rifugiati nell’estesa rete di tunnel sotterranei che rimane in buona parte intatta.
A partire da questa settimana, Israele ha iniziato a ritirare 5 delle circa 17 brigate impegnate nelle operazioni militari a Gaza. Le ragioni di questa decisione sono molteplici. La principale è di natura economica: permettere a migliaia di riservisti di tornare alle proprie attività lavorative, ridando ossigeno alla provata economia del paese.
Dal punto di vista militare, molti obiettivi sono stati distrutti, soprattutto nella parte settentrionale della Striscia. La resistenza palestinese, pur avendo subito perdite, rimane tuttavia vitale. Anche nelle aree dove teoricamente hanno il pieno controllo del territorio, i soldati israeliani sono esposti a frequenti attacchi di guerriglia. Nelle aree che non controllano, devono tuttora fronteggiare un’aspra resistenza.
Vi sono poi le pressioni americane che spingono in direzione di tattiche militari meno distruttive, per contenere lo spaventoso bilancio di vittime civili. Militarmente, si passerebbe perciò a una fase meno intensa, caratterizzata da operazioni mirate, anche se i vertici militari israeliani ci hanno tenuto a chiarire che il conflitto si protrarrà ancora per mesi.
Vi è poi, un elemento più preoccupante, citato dal quotidiano israeliano Haaretz, secondo il quale il parziale ritiro israeliano sarebbe motivato anche dalla necessità di rendere disponibili soldati per un possibile attacco contro Hezbollah in Libano.
A fine dicembre, Benny Gantz, ex generale e capo di stato maggiore israeliano, e membro dell’attuale gabinetto di guerra, aveva ammonito che, in assenza di una soluzione diplomatica per "fermare" Hezbollah permettendo così ai residenti dei villaggi israeliani vicino al confine di tornare nelle proprie case, sarebbe intervenuto l’esercito israeliano.
I vertici militari israeliani hanno dichiarato che il comando settentrionale si trova in uno “stato di massima allerta”, mentre l’attuale capo di stato maggiore Herzi Halevi ha affermato che “dobbiamo essere preparati a colpire se necessario”.
Diversi esperti militari hanno espresso scetticismo sulla possibilità che Israele apra un secondo fronte che non sarebbe in grado di controllare (visto che Hezbollah è militarmente molto più potente di Hamas, e dispone di un arsenale missilistico in grado di colpire in profondità Israele).
Israele flirta con l’escalation
Il rischio di escalation non va però sottovalutato, per alcune ragioni. Nel gabinetto di guerra israeliano vi sono alcuni falchi, fra cui il ministro della difesa Yoav Gallant, che volevano colpire fin da subito Hezbollah.
Va poi considerato il fatto che Netanyahu è potenzialmente un leader finito dal punto di vista politico. Gli eventi del 7 ottobre hanno compromesso del tutto la sua reputazione. La maggioranza degli israeliani lo ritiene responsabile dell’accaduto e lo critica per la gestione della guerra (Netanyahu non ha ancora raggiunto nessuno degli obiettivi che si era prefissato, né la distruzione di Hamas né la liberazione degli ostaggi).
Il suo stesso partito, il Likud, diviso e in crisi, comincia a considerarlo un fardello. Il governo di unità nazionale che lo sostiene, in base agli accordi stipulati ha la funzione di gestire la guerra e si scioglierà al termine delle operazioni belliche.
Netanyahu ha dunque interesse a prolungare il conflitto aggrappandosi alla speranza di riuscire col tempo a modificare a proprio vantaggio la situazione interna del paese, riacquistando un minimo di consenso.
All’inviato della Casa Bianca Amos Hochstein, giunto ieri in Israele, il premier ha detto che il ritorno dei civili israeliani nelle loro case presso il confine libanese è “uno degli obiettivi della guerra”, e “sarà raggiunto tramite la diplomazia o con mezzi militari”. Siccome appare improbabile ottenere un ritiro di Hezbollah a nord del fiume Litani (circa 30 km a nord del confine) mentre continua a divampare la guerra a Gaza, a restare sul tavolo è la seconda opzione.
In Israele vi è poi chi sogna di approfittare dell’attuale acquiescenza dell’opinione pubblica interna ed occidentale per regolare i conti una volta per tutte non solo con Hamas e Hezbollah, ma anche con il loro alleato e patrono, l’Iran. Tra costoro, figurano anche esponenti israeliani “moderati” come l’ex premier Naftali Bennett.
I sostenitori di questa opzione, ovviamente, sperano di trascinare gli USA nel conflitto. La loro idea è che, sebbene l’amministrazione Biden abbia manifestato più volte la propria contrarietà a un allargamento del conflitto, se la situazione al confine libanese dovesse andare fuori controllo (risucchiando altri attori regionali nello scontro, da Hezbollah alle milizie sciite in Siria e Iraq), gli USA sarebbero costretti ad intervenire.
Washington non potrebbe permettere che Israele, il suo principale e più fidato alleato in Medio Oriente, subisca una grave sconfitta militare. Ne andrebbe di mezzo la supremazia USA nella regione.
Strage a Kerman
Ed è proprio in Iran che il 3 gennaio, all’indomani dell’assassinio di Arouri in Libano, un gravissimo attentato ha mietuto quasi 100 vittime a Kerman, nell’Iran centro-orientale.
Una doppia esplosione, a quanto pare provocata da due attentatori suicidi, ha fatto strage tra la folla che si recava alla tomba del generale Soleimani per commemorare il quarto anniversario della sua uccisione per mano americana.
In assenza di un’immediata rivendicazione, si sono moltiplicate le illazioni sui possibili responsabili dell’attacco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha puntato il dito contro Israele. Il generale Esmail Qaani, attuale comandante della forza Quds della Guardia rivoluzionaria, ha accusato sia Israele che gli USA (i quali, secondo gli iraniani, riescono spesso a cooptare gruppi secessionisti e terroristici nel paese per i propri scopi di destabilizzazione).
Dal canto suo, Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato americano ha negato ogni coinvolgimento di Washington, aggiungendo che “non abbiamo ragione di ritenere che Israele sia coinvolto in questa esplosione”.
Miller ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime, pur astenendosi da una ferma condanna dell’attentato.
La rivendicazione da parte dell’ISIS è giunta solo dopo che era trascorso più di un giorno dall’attacco. Ed è possibile che l’attentato sia stato materialmente compiuto dalla sua branca afghana, lo Stato Islamico della Provincia di Khorasan (ISKP, secondo l’acronimo inglese). Il comunicato non ha tuttavia chiarito questo aspetto.
L’ISKP aveva in passato direttamente rivendicato diversi attacchi in Iran. L’attuale rivendicazione è invece provenuta dall’agenzia Amaq, canale “ufficiale” dell’ISIS. Responsabili americani hanno affermato di non dubitare dell’attendibilità della rivendicazione, e di ritenere allo stesso tempo improbabile che l’ISIS abbia voluto far ricadere su Israele la colpa dell’attentato per scatenare una guerra su vasta scala.
Lo stesso regime di Teheran spesso ritiene formazioni come l’ISIS manipolate dagli USA e da Israele, ma è consapevole del fatto che vi sono ambienti politici israeliani che vorrebbero trascinare gli USA in un conflitto con l’Iran, e finora ha sempre cercato di evitare un proprio coinvolgimento diretto nei molteplici incidenti regionali che, dal Libano alla Siria, all’Iraq e al Mar Rosso, sono diretta conseguenza della guerra in corso a Gaza.
La crisi di Gaza, però, rimane un pericolosissimo focolaio di destabilizzazione che sta inasprendo le tensioni regionali oltre ogni ragionevole soglia di sicurezza, riattivando i numerosi conflitti mai risolti dell’area.
La miccia è accesa
Ad appena un giorno di distanza dal terribile attentato di Kerman, la decisione americana di uccidere in Iraq, con un attacco compiuto da un drone, Mushtaq Talib al-Saidi (conosciuto anche come Abu Taqwa), comandante di campo della milizia sciita filo-iraniana Harakat al-Nujaba, e vicecomandante delle Forze di Mobilitazione Popolare (affiliate alle forze armate del governo di Baghdad), sembra indicare che Washington non abbia compreso la pericolosità delle dinamiche regionali in atto.
Gli USA consideravano Abu Takwa uno dei responsabili degli attacchi subiti dalle basi americane in Siria e Iraq in questi mesi. Ma le rappresaglie statunitensi hanno già dimostrato di non essere in grado di fermare l’escalation, ed anzi di accelerarla.
L’uccisione di Abu Takwa ha suscitato la dura reazione del governo di Baghdad per la palese violazione americana della sovranità irachena. Questi omicidi mirati, fra l’altro, paiono in contraddizione con le ripetute dichiarazioni dell’amministrazione Biden a proposito della volontà americana di non estendere il conflitto in corso a Gaza. Tali operazioni rischiano infatti di accendere un quarto fronte regionale oltre a quelli già pericolosamente caldi in Libano e nel Mar Rosso, legati a loro volta alle tragiche vicende di Gaza.
L’azione americana in Iraq giunge dopo l’impressionante progressione di attentati verificatisi in meno di dieci giorni in Siria, Libano e Iran. Fino a questo momento, Washington non ha dimostrato di saper contenere le fiamme che da Gaza minacciano di estendersi nella regione. La miccia è accesa, e gli USA non sembrano in grado di spegnerla.





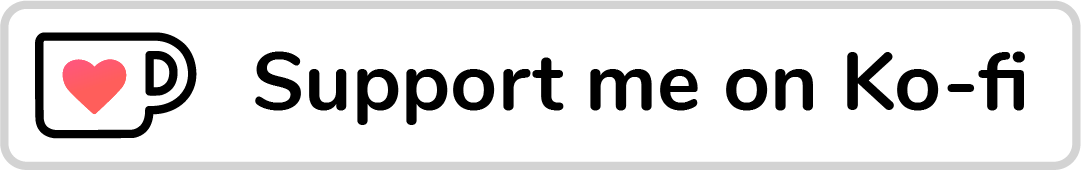
"La miccia è accesa, e gli USA non sembrano in grado di spegnerla."
Al contrario, la voglio tenere accesa fino a quando non esplode la bomba!
A proposito della situazione in Libano, è di poche ore fa la notizia secondo cui Israele avrebbe colpito un centro di comando di Hezbollah nel sud del Libano: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/army-says-it-carried-out-strike-on-hezbollah-command-center-in-southern-lebanon
Tra l'altro, questo colpo avviene proprio a poche ore di distanza dalla dichiarazione del Ministro della Difesa Israeliana, Yoav Gallant, in cui dice che il tempo per una soluzione diplomatica con Hezbollah per la situazione al confine col Libano sta scadendo e che presto non avranno altra scelta se non quella di lanciare un'offensiva militare contro Hezbollah:
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/gallant-time-running-out-on-diplomatic-efforts-to-end-tensions-between-israel-and-hezbollah/
Insomma, mi sa che ormai Israele ha deciso di aprire il secondo fronte di guerra contro Hezbollah sul Libano. Gli USA li seguiranno in questa (dis)avventura?
Ricordo di aver letto da qualche parte, ma non ricordo dove, che questa potrebbe essere una trappola mortale per Israele (e magari anche per USA e la NATO), perché all'apertura di un nuovo fronte potrebbe seguirne un altro, via via sempre più incandescente e pericoloso per Israele.